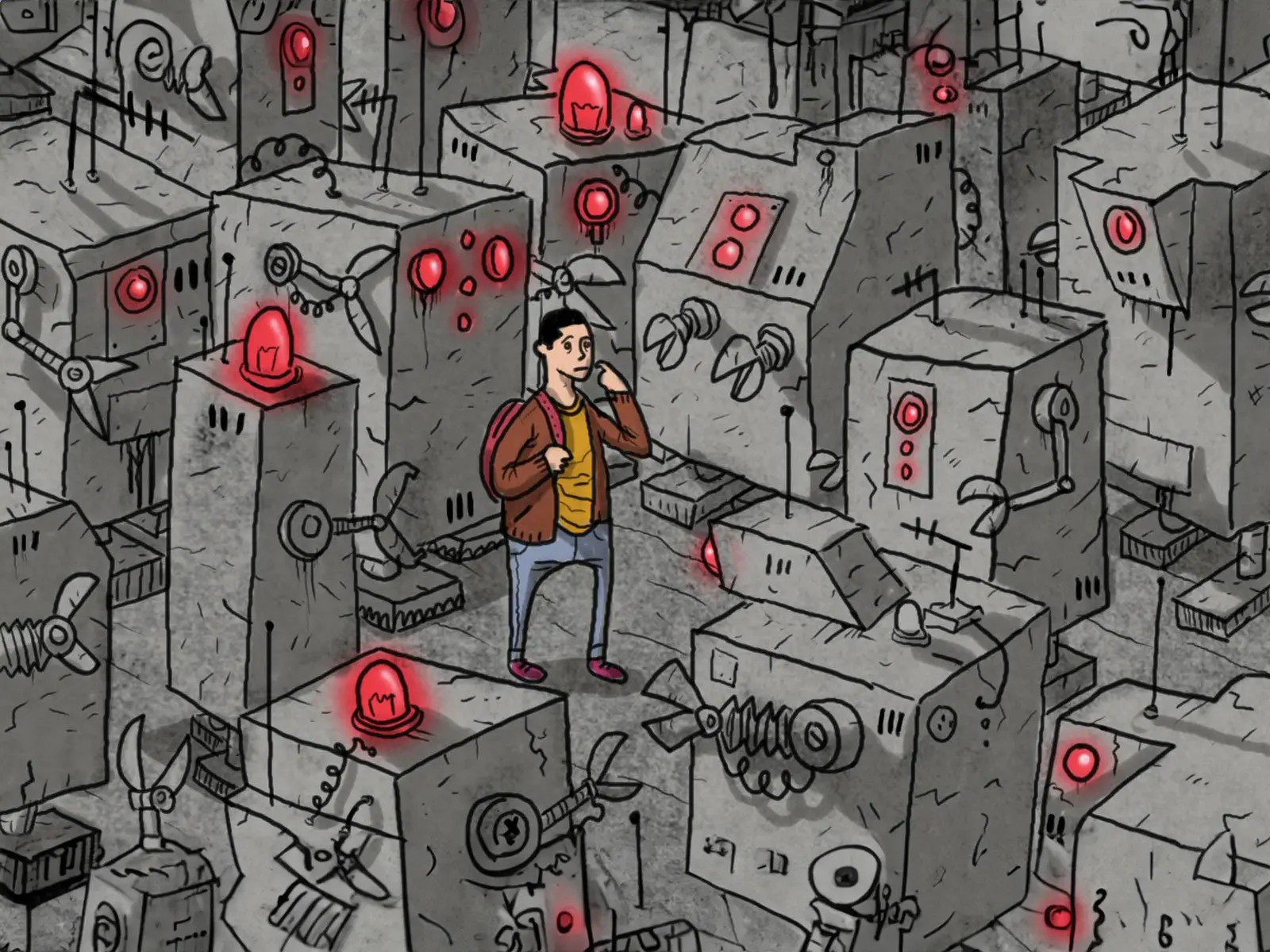
HVSR Digest #6
Courtney Barnett, A Place to Bury Strangers, Unknown Mortal Orchestra, Insecure Men e Soccer Mommy: cinque pezzi buoni per proteggersi dall'ultimo colpo di coda dell'inverno, dice il meteo.
3 Marzo 2018
Courtney Barnett
Nameless, Faceless
Piccole donne crescono
Courtney Barnett è la Courtney che tutti avremmo voluto, tempo fa a Seattle, al posto di quell'altra zoccola.
Non che ci avrebbe salvato, ma quantomeno saremmo andati a fondo beati delle nostre insicurezze con più cognizione di causa. Insicurezze che poi erano le sue: più scazzata che sexy (il termine fico per dirlo credo sia slacker), in un continuo oscillare tra l'ironia degli inevitabili pericoli di un ipotetico 21st-century living e il rassicurante terrore di qualunque interazione sociale.
La comfort zone che ci faceva sentire a casa ascoltandola è riassumibile più o meno così: Courtney Barnett aveva quell'eccezionale abilità che noi adolescenti di fine millennio abbiamo sempre apprezzato, in quanto la trovavamo un confortante accompagnamento analgesico nel processo che ha portato la nostra teenage angst a diventare bored and old a forza di sperare nel meno peggio (per rimanere in tema, la stessa che aveva Kurt Cobain — finché è durata). Si tratta della capacità di plasmare una specie di ostinata forza artistica a partire esclusivamente dalle proprie personali debolezze, di prendere tutta quella merda che senti dentro e tirarla fuori, riuscendo però a sembrare una maledetta rock star annoiata (slacker l'ho già detto?) invece che una ragazzina piagnucolosa che si sta autocommiserando.
Courtney Barnett era l'amica un po' depressa, che però ti faceva morire dal ridere per come ti raccontava le cose, quella con saresti voluto andare a bere una birra tutte le sere per sentirti dire che il mondo fa schifo ma quelli che dicono che il mondo fa schifo fan schifo di più. O almeno, io una birra con Courtney Barnett — all'epoca del suo debutto — ce la sarei andata a bere volentieri, lo confesso. Sarà che ormai le avevo provate tutte senza particolare successo, ma ero disposto senza nessun imbarazzo di sorta anche a questo tentativo da ultima spiaggia: farmi spiegare da una nata nell'87 come uscire vivi dagli anni '90, passando senza troppi traumi dal buon vecchio «I hate myself and I want to die» al suo disarmante «I used to hate myself but now I think I'm all right».
Ora la ragazzina è cresciuta, ha letto (forse un po' troppo) Margaret Atwood, cita nei video i pop-art collage di Richard Hamilton — meraviglioso, in questo senso, il lavoro di un'esperta in materia come Lucy Dyson, nel nuovo singolo Nameless, Faceless — e si fa fare i cori dall'ex-Pixies Kim Deal. Così oggi, seduti al bancone di quell'ipotetico pub, immagino dovrei sorbirmi un sarcastico — ma sempre delizioso — pippone sugli sbilanciamenti del rapporto uomo/donna a base di «Ma chi vi credete di essere? Pensate che il mondo giri solo attorno a voi?” e un sacco di altre frecciatine brillanti quanto dolorosamente attuali.
Poco male. Sarà che ho un debole per Courtney Barnett, ma io, sinceramente, sono disposto ancora a correre il rischio. Dopotutto, una birretta con una tipa intelligente è sempre una manna dal cielo: nella peggiore delle ipotesi ti ubriachi in allegria, nella migliore finisce che pure che impari qualcosa.
A Place To Bury Strangers
Never Coming Back
Quando l'unico modo per apprezzare al meglio una band è tapparti le orecchie
La storia di Oliver Ackermann ha i contorni distorti del sogno malato di un guitar nerd: uno smanettone dei circuiti a corrente alternata che invece di unirsi agli anarchici antagonisti e sabotare centrali elettriche, ha deciso di (h)ackerare — nomen omen — pedali e filtri di pre-amplificazione per sentire l'effetto che fa.
Così facendo ha equamente diviso il suo pubblico tra chi sostiene che ha fondato una band al solo scopo di testare sul campo le sue creazioni e chi invece rimane estasiato di fronte a cotanto ingegno, dichiarando senza mezzi termini che nel campo del post-punk (o comunque vogliate chiamarlo) suoni del genere non si sono mai sentiti — il che è sicuramente vero, se non altro in termini letterali, per i volumi da estremista della percezione uditiva verso cui li spinge lui.
La realtà dei fatti sta, come spesso succede, nel mezzo: da un lato è sì inconfutabile che la dimensione (soprattutto quella live) di quella che è stata semplicisticamente etichettata come "the loudest band in New York" — tra chitarre spaccate per terra, collisioni di strumenti in volo e dissezioni di sei corde senza anestesia — sfiori i confini della pagliacciata noise, dall'altro c'è il forte sospetto secondo cui, alla base del lavoro portato avanti dal guastatore della East Coast, ci sia una sorta di estetica sonora, una specie di rigoroso metodo nella pazzia: rumore, rock e paranoia, agli ordini di un'armata Brancaleone di diodi, condensatori e potenziometri saldati insieme senza via di scampo e sparati oltre i limiti di qualunque legge sul disturbo alla quiete pubblica e privata.
Dopotutto, la sua creatura l'ha chiamata A Place To Bury Strangers, mica — che ne so — The Holy Garden Where to Rest Your Head in Peace.
Comunque, manco a dirlo, rumore e paranoia la fanno da padroni anche nel video di Never Coming Back — primo singolo tratto dal nuovo album Pinned, in uscita ad aprile — non a caso diretto dallo stesso Ackermann in compagnia di Ebru Yildiz: a metà tra un Suspiria dei giorni nostri e la versione metropolitana di The Blair Witch Project, si regge quasi esclusivamente su un riff di basso apparentemente innocuo (al punto da sembrare rubato a un pezzo dei Cure), ma in realtà ossessivo e ineluttabile come la morte, prima di esplodere nel solito, adorabilmente disturbante muro di suono che finisce per essere lo sbarramento invalicabile alle fine di un cul de sac annunciato.
L'ennesimo luogo di non ritorno, appunto. Per i tuoi timpani, almeno.
Unknown Mortal Orchestra
American Guilt
Rock'n'roll restyling
Ruban Nielson mi è sempre sembrato uno di quegli artigiani talentuosi assoldati dalle major del design industriale per dare quel certo "non-so-che" alla loro noiosa produzione seriale. Una cura certosina dei dettagli sonori e un ossessivo lavoro di cesello sugli incastri tra le parti, messi in pratica con perizia estrema e il ben preciso obiettivo aziendale di ridare lustro e un certo tocco di attualità a generi musicali comunemente considerati stantii e appannati: questo lo scopo della sua consulenza, diligentemente depositato tra gli schedari del responsabile risorse umane.
Ecco, a sentire American Guilt, pare che stavolta la terapia sia toccata a un mostro sacro che ricorsivamente — da tempo immemore, ormai — tutti danno per morto un anno sì e l'altro pure. Le sue parole confermano il sospetto, senza lasciare spazio a troppi fraintendimenti:
In a perverse way I wanted to embrace this abandoned thing called "rock music" and invite people to hear what this living dead genre sounds like in the UMO universe.
E bisogna dire che di rock — in tutto e per tutto — si tratta: grezzo, ruvido e diretto, con gli strumenti che hanno dei suoni così (accuratamente, volontariamente — artigianalmente, appunto) compressi da sembrare usciti dalla radiolina con cui mio papà ascoltava Tutto il Calcio Minuto per Minuto ai tempi di Boninsegna, se non addirittura da quella con cui mio nonno comunicava con gli altri partigiani a cavallo della Linea Gotica.
Ad accompagnarlo, lo splendido video animato diretto da Greg Sharp che, grazie alla sua lenta carrellata sulla monnezza con cui il nostro consumismo sta uccidendo questo mondo (vecchi vestiti lisi, panini masticati a metà, giornaletti porno, giocattoli dismessi, valigette piene di soldi sporchi e chi più ne ha più ne metta), ci ricorda che — prima o poi — dovremo pagare per tutto ciò. Anche solo per il fatto che a breve arriva la prima rata della TARI.
Sex & Food esce il prossimo aprile su Jagjaguwar e, se tutto il resto del disco degli Unknown Mortal Orchestra sarà appagante per l'udito quanto il titolo lo è per gli altri sensi, direi che siamo a posto. In fin dei conti — come anticipavamo — il rock ce lo mette, a modo suo, questo primo singolo e così "sex, food & rock'n'roll" si candida già al ruolo di ineluttabile, santissima trinità del nuovo millennio.
Sì, perché, dopotutto, cos'è il cibo, se non una droga a tutti gli effetti? Ne sono fermamente convinti tutti gli specialisti (che siano medici, ristoratori o esperti di marketing), ma comunque, in caso abbiate ancora qualche dubbio al riguardo — anche senza andare a scomodare commoventi storie di grandi obesi — provate a dare un'occhiata alla vostra timeline di Instagram.
Insecure Men
I Don't Wanna Dance (with My Baby)
Mille modi per non farsi tirare in ballo
Ballare o non ballare? Questo è il problema. Seguire l'istinto o trattenersi? Agli Amici di Maria de Filippi l'ardua sentenza.
E quando non c'è nessun istinto da seguire, che si fa? Perché è vero che, volendo, imparare si impara e, riguardo all'offerta, sui corsi di ballo c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma la voglia di ballare, quella non te la può mica insegnare nessuno: quella, o ce l'hai o non ce l'hai.
Insomma, qualunque sia la risposta, è una decisione che divide a prescindere: a qualcuno sembrerà più che naturale, a qualcun altro assolutamente incomprensibile, ma nessuno che riesca — come spiegava molto bene qualche anno fa un tizio su Medium — a rispettarla o accettarla per quella che è, ovvero una banale propensione naturale, in cui possono avere pesi diversi non solo orecchio e senso del ritmo, ma anche componenti meno gestibili come vocazione a esibirsi, tendenza a non apparire o semplice insicurezza cronica.
Manco a dirlo, gli Insecure Men entrano a gamba tesa nella questione, anche se la affrontano con fare contraddittorio: da un lato sciorinano dei groove così maledettamente pop a cui i movimenti inconsulti del tuo bacino faranno fatica a resistere, dall'altro fanno dell'insicurezza — oltre che parte integrante del proprio moniker — a tutti gli effetti uno stile di vita. Per dire, non son nemmeno così certi del numero dei componenti della band: formalmente un duo (composto da Saul Adamczewski dei Fat White Family e Ben Romans-Hopcraft dei Childhood) dal vivo arrivano a stipare fino a undici musicisti sul palco, per mettere insieme un allegro, traballante spettacolino da circo itinerante, solo apparentemente campato in aria, a suon musichette sghembe e pseudo-retrò, che a tratti ricordano la versione lo-fi dei Pulp più scazzati.
E allora quale miglior video per il loro terzo singolo I Don't Wanna Dance (with My Baby), tratto dall'imminente debutto su Fat Possum, se non quello girato da Jak Payne? Un contest di ballo per bimbetti ambientato a Blackpool, che sarebbe un posticino rimasto un po' indietro nel tempo, ai confini della più sperduta periferia costiera inglese: una roba deliziosamente datata e kitsch, con ragazzine truccate come bambole anni '70 e dodicenni vestiti come Tony Manero, in mezzo ai quali cantante della band, con la sua faccia a metà tra il Frank Gallagher di Shameless e l'ex-Verve Richard Ashcroft, si mimetizza maluccio, sfoggiando delle borse sotto gli occhi che la Ryanair non ti passerebbe come bagaglio a mano e una dentatura degna del (mai troppo) compianto Mark E. Smith.
Insicuro come pochi — nascosto in un pubblico di mamme, nonne e parenti vari — se ne sta in ultima fila e, con lo sguardo da cane bastonato, fa la fine di Nanni Moretti in Caro Diario: si riduce a guardare. Che è anche bello, però… è tutta un'altra cosa.
Soccer Mommy
Your Dog
La ragazzina che non era d'accordo né con Iggy né con gli Stooges
Un'adolescenza introversa, passata a comporre canzoncine chiusa nella propria cameretta — ci sarà un motivo se il bedroom pop è considerato a tutti gli effetti un genere musicale a parte con una sua sottile dignità, no? — e a pubblicarle solo su Bandcamp, finché qualcuno non ti comunica ufficialmente che magari con quella roba c'è pure la possibilità di tirarci su due soldi e ti introduce in un mondo polveroso dove le cose di fanno ancora un po' all'antica, tramite strumenti vetusti come etichette e contratti discografici.
Messa così, quella di Sophie Allison sembra la storia della sorella gemella di Will Toledo, che, alle soglie della maggiore età, finalmente se ne guadagna una tutta sua (di camerette, dico), dopo un'infanzia in comune, durante la quale ha condiviso con il fratellino talentuoso e occhialuto lo stesso letto a castello dell'IKEA, musicalmente costruito all'insegna dell'ingegno e del risparmio, ovvero seguendo alla lettera le istruzioni minimali di un'etica (e un'estetica) rigorosamente DIY.
Come i Car Seat Headrest infatti, anche il progetto Soccer Mommy vanta il primato di aver esordito con un greatest hits, ed essere poi arrivato all'effettivo primo album con il secondo disco. Un po' macchinoso, come concetto, ma a quanto pare è la nuova frontiera della promozione musicale, baby.
In questo caso, l'uscita di Clean è prevista per i primi di marzo e Your Dog è il singolo ha fatto iniziare il conto alla rovescia: la storia viscerale di chi trova il coraggio di fuggire da una relazione tossica, capitalizzando un improvviso momento di lucidità dopo un infinito periodo di debolezza. Storia raccontata con invidiabile humor nero dal collettivo di film maker Weird Life nel relativo video che, a livello di storytelling, pare la versione emo del buon vecchio Weekend con il morto. Emo nel senso che il morto in questione non è il datore di lavoro, ma il fidanzato della protagonista, la quale, a sua volta, aggiunge emo all'emo, visto che, per poterselo portare appresso senza dare nell'occhio, invece di mettergli su un paio di occhiali da sole come nel film di Ted Kotcheff, pensa bene di truccarlo come il cantante dei My Chemical Romance.
Il messaggio è semplice quanto diretto («I don't wanna be your fucking dog») e, fin dalle prime righe, mette subito in chiaro che abbiam perso ogni traccia, qui, della dolce vulnerabilità che permeava le prime composizioni della Allison di un paio di anni fa. Cosa prevedibile, dopotutto: crescendo, quel che non ti ammazza di fortifica e anche ad ammettere di sentirsi invisibili ci vuole non poco coraggio. Ancor di più se, nel farlo, finisci per ribattere, punto su punto, parola per parola, involontariamente o meno, a gente come questa.