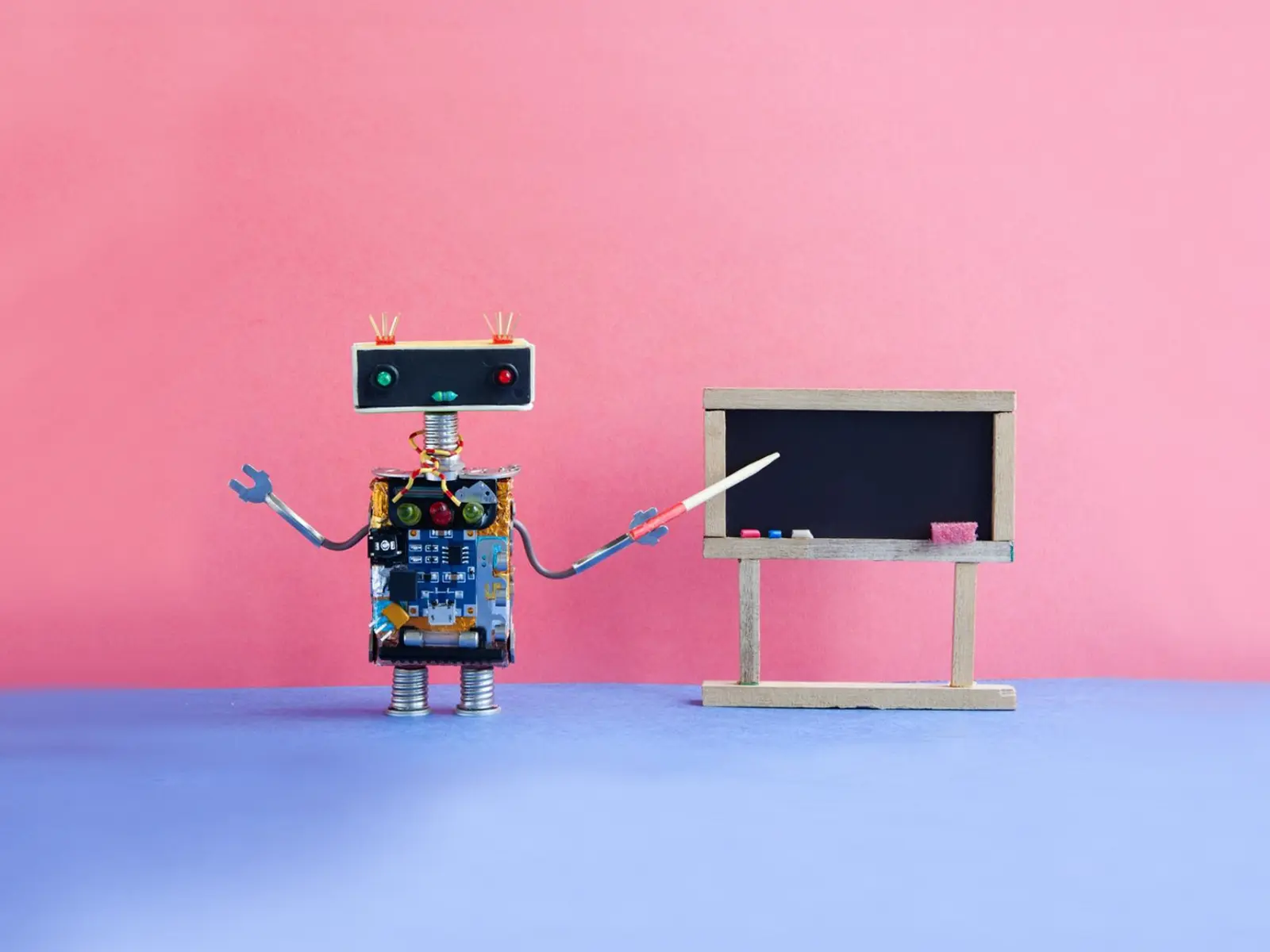
HVSR Digest #15
Ian Brown senza gli Stone Roses, quel diavolo d'un Caso, i redivivi American Football, i Manchester Orchestra e l'Avversario: cinque pezzi buoni per ripigliarsi dopo le feste.
16 Gennaio 2019
Manchester Orchestra
The Silence
Giocare al gioco del silenzio facendo tutto il rumore necessario
Come ogni vuoto o assenza, raccontare il silenzio è così complicato che, paradossalmente, vale tutto. Da un estremo a un altro, se John Cage aveva scelto il modo più ruffiano regalandoci 4:33 minuti stracolmi di nulla, i Manchester Orchestra decidono di farlo — in maniera opportunamente cinematica e rarefatta — confessando quanto rimbomba la vita reale attraverso la sua eco ingombrante che, nel silenzio, finisce per amplificarsi.
The Silence è la traccia che — idealmente, concettualmente e cronologicamente — conclude il loro A Black Mile to the Surface, un album risalente ormai a quasi due anni fa e che nel 2017 fu in pratica completamente ignorato in qualunque bilancio di fine stagione, ma su cui (come per tutti i dischi che necessitano le capacità e i tempi digestivi di un pitone delle rocce africano) verseremo opportuni fiumi di lacrime di coccodrillo quando, tra dieci anni, faremo le classifiche di dieci anni fa.
Non c'è niente di male: dopotutto ogni silenzio è un'esplorazione alla cieca e rivalutare i propri a distanza di tempo almeno è un indizio che stai chiudendo il cerchio. O che almeno hai trovato una traccia da seguire per approdare da qualche parte.
Quando si tratta di una canzone, la cosa spesso si traduce nell'ultimo verso e qui, nello specifico, «Let me open my eyes and be glad that I got here» riporta tutto (e tutti) a casa, mandando a quel paese Thomas Stearns Eliot e Tiziano Terzani, Gotthold Ephraim Lessing e i creativi della Campari, le teorie dell'amore tantrico e la pratica dell'eiaculazione precoce o, in generale, tutti quei gran cervelli che — con i piedi scalzi per la strada o il culo ben piantato su una sedia, indifferentemente — non hanno comunque voluto perdere l'occasione di pontificare su percorsi, punti di arrivo e prospettive di raggiungimento — a breve o lungo termine — di miraggi all'orizzonte.
Perché magari è vero che il bello del viaggiare è il viaggio in sé e non la meta e che l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, ma anche sapere dove si sta andando e — magicamente o meno — ritrovarsi proprio lì, conforta come la conclusione di un'odissea domestica e aiuta a non perdersi. O quantomeno a inciampare con più consapevolezza.
Se poi c'è qualcuno che ancora ha il coraggio di sostenere che provare a dire tutto questo con una traccia di otto minuti è un controsenso, mi spiace, ma di viaggi, di attese e soprattutto di piacere, non ha capito un beneamato cazzo.
Caso
Fosbury
Canzoni che non piacciono alla gente, o forse sì?
L'hinterland di Bergamo non deve essere poi così diverso da quello di Ferrara: un orizzonte disteso a perdita d'occhio in quell'irresistibile nulla padano, solo idealmente confinato tra un film dell'orrore sbiadito, un'autostrada con visibilità ridotta causa nebbia e, sullo sfondo, le luci aliene di una qualche centrale elettrica.
Non a (perdonate l'inevitabile gioco di parole) caso, Andrea Casali, si porta dietro ormai da anni la scomoda etichetta di un Vasco Brondi che non ce l'ha fatta. Per fortuna, verrebbe da dire. Perché in questo modo — mentre la parabola brondiana consumava tutto il proprio arco fino a cortocircuitare volontariamente il suo lume per evitare di essere spremuto fino alla buccia da quella sanguisuga che è il concetto di "indie italiano" — Caso si è potuto permettere il lusso di non diventare nessuno, sempre fedele al suo piccolo mantra punk che gli impone di non confondere mai popolarità con qualità e successo, continuando a fare il suo mestiere e cioè quello (come lo chiama lui, con quel tocco paraculo di chi mente sapendo di mentire) di «scrivere canzoni che non piacciono alla gente».
Così è andato avanti per quattro album, sempre convinto che ogni disco nuovo fosse l'ultimo. Non c'è mai riuscito. Non ancora almeno, visto che Ad ogni buca è il quinto (il secondo, dopo il precedente Cervino, in cui abbandona la solitudine acustica per un sound più elettrico sorretto da una vera e propria band) e — come ogni suo disco prima del prossimo — già in un attimo riesce a far impallidire i precedenti, riportandoci senza particolari rimorsi dentro fino al collo in quell'alt-rock secco e scarno che avevamo cercato di dimenticare dopo gli anni '90, suonato come si faceva a quei tempi là: in tre — chitarra, basso e batteria.
Il resto (intendo le cose che canta, e le parole che sceglie da infilare una dietro l'altra per cantarle) è talento allo stato puro: piccole storie di un'epica quotidiana che uniscono stralci di vita comune, decontestualizzandoli e rendendoli universali. Adolescenziale, diranno i suoi detrattori che quelle storie le hanno dimenticate. Post-adolescenziale, diranno coloro che quelle storie se le sentono prudere addosso anche se non vogliono ammetterlo.
Può darsi, ma la domanda è un'altra, ovvero: dove sta la differenza? Appurato che — qualcuno a un certo punto deve pur dirvelo — non si cambia mai, che cos'è l'adolescenza se non quel periodo in cui ci siamo fatti vedere per quello che siamo, giusto un attimo prima di chiudere paure e ambizioni dentro un baule facendo ben attenzione a lasciar le chiavi dentro?
Nel senso, se questa deve essere la nostra presunta maturità, ben venga l'amarcord.
American Football
Silhouettes
Post-rock dentro e fuori
Il mondo prima dell'internet, visto da qua (dai tempi dell'internet, intendo) fa quasi tenerezza, se non addirittura — musicalmente parlando, soprattutto — pure un po' di nostalgia.
Per dire, è così evidente che certe band il loro nome l'hanno scelto in un periodo in cui le informazioni ancora dovevi andartele a scovare in posti che esistevano davvero (giornali, redazioni, concerti, dischi), senza nemmeno poter immaginare l'attuale, sconfinata e incrollabile fiducia nell'orientamento a (s)vista sulla superficie di un virtuale World Wide Web.
Nel senso, provate pure a digitare "american football" sul vostro amato Google, ma non aspettatevi niente di diverso che una lista di risultati buoni giusto per farvi una cultura su quarterback, Superbowl e campionato NFL in generale.
Un EP risalente ai giorni in cui l'unico strumento disponibile per non perdersi online era AltaVista (ovvero un motore di ricerca che non ha mai funzionato), un primo disco l'anno dopo, diciassette anni di silenzio, un secondo album nel 2016 e un terzo in uscita a breve. Tutti, rigorosamente, intitolati soltanto American Football. Così, per mettere in ulteriore difficoltà i naviganti con poca fantasia in termini di keyword.
In pratica, Mike Kinsella e soci — gente di poche parole per natura, in quanto post-rock dentro — mentre la nostra società diventava il mostro digitalizzato che abbiamo sotto gli occhi, sono andati a letto presto e la mattina, di buon ora, hanno atteso lungo la riva del famoso fiume il suo cadavere scomposto in bit e byte.
Riprendono il discorso con un pezzo di sette minuti e mezzo, per gran tratti strumentale, analogico nello spirito e totalmente anti-commerciale per la struttura: fuori luogo e fuori tempo, da mordere senza fuggire e assaporare con una calma a cui le nostre papille gustative interrotte dalla frenesia di un clic selvaggio non sono più abituate.
Comunque vada sarà un (in)successo.
Ian Brown
First World Problems
Occhio ad autocitarsi troppo, che poi si diventa ciechi
Riassumiamo il tutto con la poesia ermetica (solo parzialmente attenuata da una tenera quando innocua rima baciata) di uno stagista dell'ANSA: il (non più) ex-cantante degli Stone Roses torna in pista con un nuovo singolo da solista.
Ora proviamo ad analizzare parola per parola questo solo apparentemente banale lancio d'agenzia: in una manciata di battute è riassunta l'intera vita di un uomo e, in particolare, la sua movimentata carriera fatta di alti e bassi alternati a tira e molla, sempre e comunque ballati attorno a una delle più importanti band del cosiddetto britpop. Poche, misere parole per immaginarsi la parabola sinusoidale di questo tizio che un tempo era il cantante degli Stone Roses, ma che poi ha sciolto gli Stone Roses e ha intrapreso una brillante svolta solista, che successivamente ha chiuso baracca e burattini per un bel po' di anni e adesso, una volta riformati gli Stone Roses ed essendo tornato a tutti gli effetti a essere il cantante degli Stone Roses, pare tutt'altro che propenso ad abbandonare il progetto parallelo incentrato su se stesso e non avere nessuna intenzione di smettere di prendersi cura del suo orticello in cui coltivare fondamentalmente gli stessi fiori e le stesse pietre, ma senza gli altri del gruppo che gli dicano con quanta acqua innaffiarle e quali fertilizzanti usare, lasciando così adito a tutte le speculazioni del caso riguardo a un eventuale, ennesimo scioglimento di una delle più importanti band del cosiddetto britpop.
Ottimo lavoro, insomma: il ragazzo promette bene e meriterebbe di essere promosso almeno al ruolo di pubblicista. Lo stagista, dico.
Ian Brown invece ragazzo non lo è più da un po', ma il suo ego si sente lo stesso addosso poco più di vent'anni e infatti torna a far capolino con un singolo (che anticipa il nuovo album Ripples, in uscita a marzo) in cui non perde l'occasione di citare se stesso in quello che è a tutti gli effetti un omaggio allo specchio piuttosto che una semplice operazione-nostalgia.
Bisogna dire che — non necessariamente la cosa è un male — i segni della vecchiaia ci sono in realtà tutti e vanno ben oltre gli ottimi capelli brizzolati: il set spostato da un brulicante centro città a una bucolica campagna rurale, la bici non più così certa della sua direzione ostinata e contraria ma che oscilla in un avanti e indietro vagamente indeciso e soprattutto, tra le righe, la conferma tardiva di uno dei più grandi talenti (forse sprecato) del pop contemporaneo.
L'avversario
Le feste
Capodannato
Il tema del doppelgänger sta sicuramente almeno sul podio di quelli che più hanno affascinato l'uomo dai tempi di Romolo e Remo all'attuale governo del cambiamento. La lista dei vari (dai più scientifici ai più bislacchi) approcci alla questione, anche divisa per ambiti culturali, sarebbe infinita: le barzellette con il poliziotto buono e quello cattivo, Jung e la sua psicologia analitica, tutta la letteratura costellata di Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dorian Grey, sosia dostoevskiani e visconti dimezzati — per non parlare del cinema (Lynch su tutti), fino alla musica con gli epici scazzi tra i fratelli Gallagher e il recente, doloroso split di Paola e Chiara.
Da sempre, immagine simbolo della faccenda è stata lo specchio, croce e delizia del rapporto con il proprio doppio e catalizzatore automatico delle più disparate reazioni: c'è chi non può sopportarli (tipo i vampiri e tutti coloro che hanno fatto qualcosa di cui vergognarsi), chi non riesce a evitare di fermare a guardarsi ogni volta che ne incrocia uno (anche solo per controllarsi l'acconciatura) e chi è ormai completamente schiavo della sua manifestazione 2.0, ovvero la camera frontale dello smartphone.
Lo specchio, è proprio il titolo del primo disco solista di Andrea Manenti (in arte L'Avversario, dall'omonimo romanzo di Emmanuel Carrère), uno che certo non ama le soluzioni facili e non ha paura di guardarsi dentro per cercare strade poco battute da percorrere con beata (in)coscienza. Debutta infatti con un lavoro tanto audace quando complesso: uno studio-work scritto, ideato e suonato interamente in sala di registrazione secondo l'espediente compositivo del canone inverso.
Un album concettualmente (non grammaticalmente, altrimenti sarebbe stato il disco di Stefano Bartezzaghi) palindromo, che si snoda attraverso coppie di canzoni "avversarie", appunto, che non sono altro che l'una il reverse dell'altra: la prima e l'ultima, la seconda e la penultima, fino al brano centrale, oltre la cui metà tutto ciò che abbiamo ascoltato in precedenza ci viene riproposto di nuovo, ma nel senso inverso.
Le feste — girato a Villa Toeplitz (la cosa più simmetrica che c'era nei dintorni di Varese) da Ivan Vania — è la colonna sonora perfetta per tutti coloro che hanno intenzione di passare il capodanno chiusi in casa, in un volutamente decadente e disincantato faccia a faccia con se stessi, a crogiolarsi in una visione puramente epicurea del mondo, in cui ogni moto umano (in particolare un brindisi con il prosecco o due fuochi d'artificio in croce) risulta superfluo: un esercizio — come l'intero lavoro di Manenti — di sana allegria, cervellotico e complesso, ma proprio per questo assai intrigante eppure, sorprendentemente, per niente snob e del tutto accessibile.