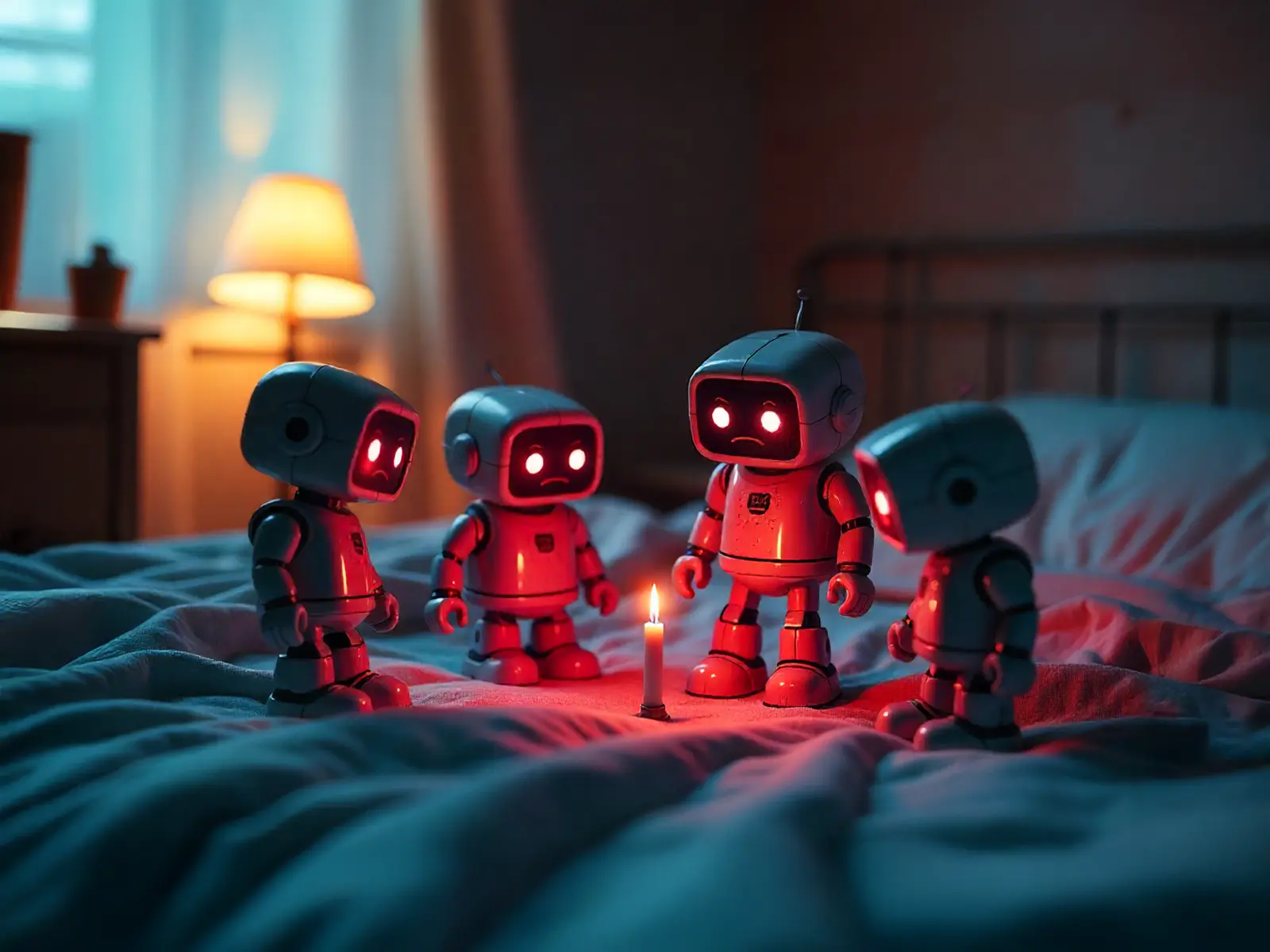
HVSR Digest #25
DJ Shadow con i De La Soul, Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo, Moses Sumney, Sam Fender e i King Of The Opera: cinque pezzi buoni per buttare l'anno vecchio dalla finestra e ritrovarselo che bussa alla porta camuffato da anno nuovo.
8 Gennaio 2020
DJ Shadow (feat. De La Soul)
Rocket Fuel
Le prove schiaccianti che il mondo sta andando a rotoli, servite su un tappeto di ratatouille old skool
DJ Shadow è tornato. E c'ha pure le palle un po' girate.
C'è da capirlo, tutto sommato: viviamo in tempi ridicoli, in cui tocca ridere per non piangere. E se da un lato il riso fa buon sangue, dall'altro — si sa — abbonda pure sulla bocca degli stolti. Il che la dice lunga sul livello di annebbiamento mentale necessario per uscire da un metaforico prelievo con gli esami a posto, al giorno d'oggi.
Fake news, no vax, teorie del complotto applicate a catena fino a negare l'evidenza. E allora perché non festeggiare i cinquant'anni dell'allunaggio riportando in auge — a proposito appunto di cospirazioni e ipotesi bislacche — la bufala vintage forse più divertente di tutte? Sì, quella secondo cui fu tutto un falso girato in studio da Stanley Kubrick. Alla fine, dopo quel famoso "piccolo passo per l'uomo", l'umanità — contro ogni previsione e speranza — non ha fatto che inanellare sì una cospicua serie di grandi balzi, ma indietro. Quindi non fa una piega.
Da qui parte infatti Rocket Fuel per lanciare qualcosa di simile all'hip-hop giù a rotta di collo per una discesa funk-punk (chiamiamola phunk) con un "tiro" che non ricordavamo dai tempi di certe paraculate mainstream di Fatboy Slim o di oscuri sussulti di nicchia come la roba migliore dei Go! Team. Una slapstick comedy a gravità (quasi) zero che manda in caciara il duello di C'era una volta il West affogandolo nel polverone satellitare.
Dopotutto, fin dai tempi di Endtroducing..... (ufficialmente riconosciuto come il primo album completamente campionato — in altri termini: musica originale fatta esclusivamente con musica di altri), Joshua Paul Davis si è sempre posto come maestro del fake applicato al reale. Mancava solo la ciliegina sulla torta, ovvero riuscire a infilare un «ready, set / steady, bet» in un pezzo rap senza risultare ridicoli (che, a livello di difficoltà, corrisponde esattamente a mettere un bello «yeah!» in apertura di un tormentone rock e sperare che qualcuno continui a prenderti sul serio).
Per quello, ci voleva tutta l'autorevolezza (e la faccia come il culo) dei De La Soul. Fatto.
Manuel Agnelli (feat. Rodrigo D'Erasmo)
Video Games
Fuori da Marylin, dentro Lana Del Rey
Pianoforte e violino, ovvero gli strumenti radical chic per eccellenza. Lui sempre più simile a una Patti Smith con la barba. Il bianco e nero ammiccante, le luci soffuse. Il ciuffo di Rodrigo D'Erasmo, le sue unghie smaltate di scuro, grossolanamente. I punti di appiglio perché il tutto si risolva in una banale presa per i fondelli dell'operazione in toto sono innumerevoli. Eppure l'impressione è quella di sentirsi a casa: una sensazione quasi liberatoria, una storia da raccontare sottovoce per poi gridarla all'improvviso.
Manuel Agnelli ultimamente è ovunque e mai dove te lo aspetteresti. Dalla colonna sonora di 1994, al bancone di Germi. Ha condotto Ossigeno su Rai 3, lo hanno intravisto al Lucca Comics con Gipi, presenta il documentario Berlino Est Ovest su SkyArte, gira i teatri con uno spettacolo in terza persona — An Evening with Manuel Agnelli (da cui è tratta questa cover).
Non ha paura di esporsi, questo è certo. Sparate pure al soldato Manuel. Tanto saranno sempre colpi a salve e in ogni caso arrivereste con un attimo di ritardo, voi segugi senza indugio del primo passo falso. Perché qui la questione non è più (ammesso che lo sia mai stata, sul serio) una derelitta guerra dei poveri tra indie e mainstream o il rock che flirta col pop per mettere le mani avanti. Non si tratta di giudicare o prendere le distanze, celebrare o giustificare scelte e decidere se sono state coraggiose, naturali, premeditate. Svendere il culo o vendere cara la pelle.
Qui c'è uno che aveva tutto in testa e ha provato a dirlo. Nel farlo, ha disegnato cose memorabili e — probabilmente — pestato qualche bel merdone, consapevole che bisogna sceglier bene tanto quanto sceglier presto. Ben conscio che il fallimento è un grembo, mentre la sicurezza ha un ventre tenero, ma è un demonio steso tra te e il senso della tua carriera. Quello che è indiscutibile è che è sempre stato un passo avanti alla media musicale di questo Paese, e quando sei sempre un passo avanti è indubbio che sia più difficile prevedere cosa ti finirà sotto le scarpe.
Proprio per questo, qualunque cosa sia, sarà qualcosa di cui — alla fine — andare orgogliosi.
Moses Sumney
Virile
Tutte le cinquanta sfumature di prodigio
«A conceptual patchwork about grayness» recita la press release di græ, il secondo album di Moses Sumney, che vedrà la luce in due parti, nel corso dei prossimi sei mesi. Ovvero — provando a sorvolare sul malcelato (quanto mal riuscito) tentativo di poesia — "un accrocchio concettuale sul grigiore". Direi che fa già ridere così. E comunque, se nel quasi 2020 ancora confidate sulle parole di un comunicato stampa per farvi l'idea di un disco, non saranno certo questo paio di righe a salvarvi dall'estinzione.
Eppure, in fondo al barile delle frasi a effetto, c'è uno strato di verità. Infatti, dopo aver passato l'intero album di debutto a crucciarsi di quanto sia un peccato non riuscire più a sperimentare il vero amore romantico nell'era di Tinder, l'artista californiano adesso allarga la visuale del suo rammarico e prende atto dell'attuale drammatica assenza di valori assoluti, abbracciando la miriade di toni di grigio che ogni giorno sconfigge la visione di una vita in bianco e nero. Niente che non sia già stato fritto e rifritto a più voci, insomma: dalle pippe indie dei Pavement agli ammiccamenti di qualche blockbuster soft-porn.
Ma qui la storia è diversa. Perché Moses Sumney eccelle quando alza il livello della sfida. Sfida sia di genere (ovvero su quanto sia complicato definire la sua produzione), che di aspettative (ovvero sui modi che trova per presentarla).
Virile lo vede — come pretende il titolo — bello come una costata di manzo al sangue appesa al chiodo della cella frigorifera di una macelleria, unto al punto giusto e con la tartaruga ben in evidenza. Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Per il resto, scommetteresti ancora su un certo R&B liscio da lasciar scivolare sotto le lenzuola e invece ti ritrovi con una stretta alle palle che ti fa mancare il fiato, fatta di accordoni che saprebbero di crossover nu-metal, se non fossero schiacciati come un insetto sul pianoforte.
È la bellezza brutale del post-umano, il soul che si fa spina nel fianco, l'ennesimo passo avanti della musica black.
Sam Fender
Saturday
Il fenomeno dei fighetti con la chitarra, combattuto dall'interno
Praticamente già un mito dalle sue parti, Sam Fender si è guadagnato la reputazione di belloccio che non deve chiedere mai e l'acclamata candidatura a sfavillante promessa (data dai bookmaker d'oltremanica ormai pressoché per mantenuta) del pop fatto con la chitarra elettrica. D'altra parte, con quella faccina pulita da James Dean perbene e un cognome così, la strada era praticamente segnata e lastricata più di scelte obbligate che di buone intenzioni.
Eppure lui c'ha messo del suo, e di questo bisogna dargli atto. Nel senso, avrebbe potuto tranquillamente godersi una pacata, semplice (e soprattutto dorata) carriera da George Ezra 2.0 — ovvero un biondino da sposare, senza brufoli e disposto a tirare a campare su un paio di singoli indovinati, buoni giusto per gracchiare fuori dagli speaker bluetooth appoggiati sul tavolino di plastica della grigliata in giardino di suo zio — e invece se ne è uscito con un album di debutto in cui, in termini di temi complicati, non si fa mancare nulla. Dallo strazio dei bambini nella striscia di Gaza, all'attualità di una mascolinità così tossica da portare al suicidio, ai drammi irrisolti della vita nelle piccole città di periferia.
Saturday brilla in quest'ultima categoria, nei panni sgualciti di un'ode alla miseria di una settimana di lavoro lento e sfinente, un conto corrente bancario vuoto come il tuo entusiasmo e il conforto del weekend che quasi mai è all'altezza delle aspettative. Sono i Radiohead di Pablo Honey che avevi chiuso fuori dalla porta e ti ritrovi sotto lo zerbino, Paolo Nutini che canta Springsteen, i figli dei Rolling Stones in gita a Top of the Pops.
Ultima nota di merito al video, dove lascia saggiamente la scena a Matt King — meglio noto come lo strafattissimo Super Hans di Peep Show — che per l'occasione giura di averci regalato «the greatest dance performance ever filmed». Che dire? Christopher Walken rimane inarrivabile, ma c'è indubbiamente una discreta dose di talento anche qui.
King of the Opera
Monsters in My Heart
Ognuno ha i propri mostri in fondo all'anima, qualcuno ce li ha più belli degli altri
Quando — ormai quasi quindici anni fa — Alberto Mariotti fece capolino sui palchi di una città che con il blues cominciava a perdere il feeling di un tempo, non tutti ne compresero a fondo la portata. Seduto su una sedia da scuola elementare, con in braccio solo una chitarra acustica su cui menare le mani e in gola quella voce che sembrava cresciuta tra la melma del Mississippi invece che sulle rive dell'Ombrone, lasciava interdetti. Certo, il moniker che si era — consapevolmente e forse provocatoriamente — scelto non aiutava: "Samuel Katarro" suonava di merda, diciamocelo. Lui invece, suonava da Dio e il talento era tutto lì: quello nudo e crudo di un bluesman solitario, waver nel profondo. Quasi spaventava, messo in mostra così, senza il minimo pudore o filtro.
Ma il talento, appunto, non mente perché non sa mentire e quindi è andata che il suo percorso stilistico ha mantenuto tutte le promesse, consacrandolo brillante sperimentatore fuori dai confini del Mi di settima, capace di tutto e di più, dal pop delicato e bizzarro al folk psichedelico traboccante di un retrogusto a volte carnascialesco.
Torna adesso, un po' a sorpresa, con il suo progetto King of the Opera e il nuovo Nowhere Blues, chiaro rimando — almeno nel titolo — a quell'usanza del primo dopoguerra, tacitamente concordata nel giro, di omaggiare con un disco intero o un singolo brano la città che lo aveva ispirato, qui opportunamente aggiornata a un mondo moderno in cui le radici si fanno sempre più confuse.
Monsters in the Heart abbandona certi schemi cantautorali classici per approcciare un atto compositivo più libero e creativo, lascia da parte la vecchia idea compiuta di canzone — con melodia, accordi e tutto il resto — e sviluppa una minuscola particella sonora, lasciandola rigenerarsi in una sequenza modulare di se stessa, per finire in quello che potrebbe essere shoegaze elettrico, post-rock, o qualunque altra cosa.
Non sarebbe nemmeno dovuto finire nell'album. E invece, come spesso accade, i ripensamenti dell'ultimo minuto si rivelano le scelte che avrebbero meritato di essere abbracciate fin dall'inizio.