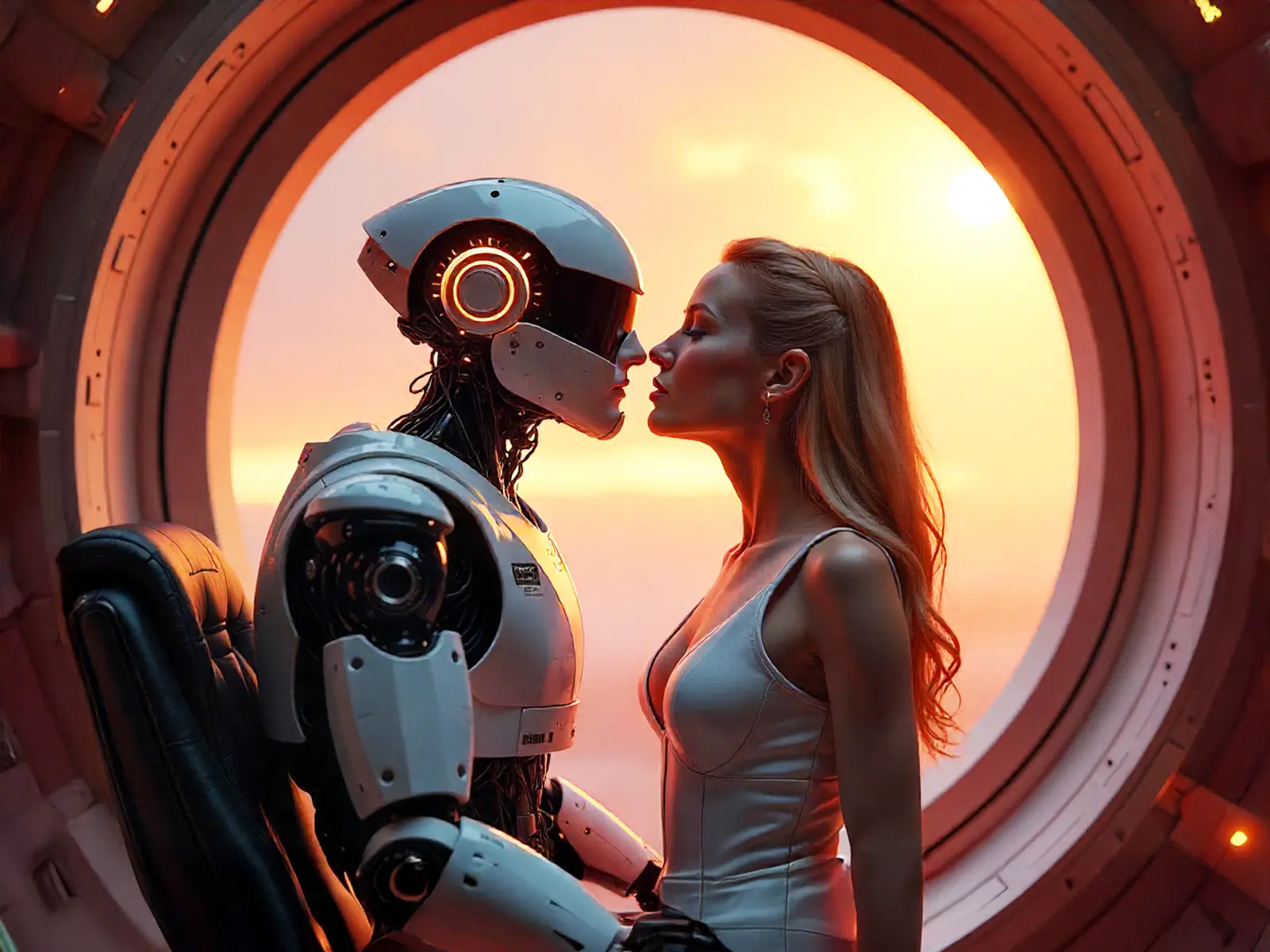
HVSR Digest #27
I Non Voglio Che Clara, Bougainville, Winona Oak, Flamingo e i National alle prese con gli INXS: cinque pezzi buoni per ammazzare qualunque santo, figuriamoci quella fighetta di San Valentino.
7 Marzo 2020
Non Voglio Che Clara
La Croazia
In un mondo it-pop ideale, il prossimo tormentone estivo
Gente con una certa coerenza verso la propria poetica, che mai perde il gusto di carezzare il proprio spessore artistico. Gente che ha preso il nome da un romanzo di Pennac quando ancora i libri erano robe di carta. Gente così, radicata nei propri — piccoli o grandi che siano — riferimenti geografici, bella di uno strabismo forzato, con un occhio sempre rivolto avanti e l'altro a guardare indietro i luoghi — reali o dell'anima, non fa differenza — che con il tempo e i chilometri si sono fatti cari.
Gente che ha avuto il coraggio di fare colazione al Caffè Cortina, che ha soggiornato all'Hotel Tivoli con il buongusto di non recensirlo su Tripadvisor. Gente che ha parlato Dei Cani quando I Cani sguinzagliati sulla cresta dell'onda erano ben altri. Gente che ha creduto nell'amore fino all'ultimo momento in cui è durato e ora — dopo sei anni di silenzio sulla lunga distanza — torna preda di uno spleen così peso da risultare super e richiedere addirittura di essere rilasciato in due volumi.
I Non voglio che Clara, dalle montagne bellunesi arrivano a pucciare i piedi nell'Adriatico con sonorità che dire attuali è poco. È un presente che contemporaneamente si fa passato e futuro, all'ora dell'aperitivo ma il più lontano possibile dal Papeete. Racconta la transizione dall'adolescenza all'età adulta senza passare da Instagram, con un tutorial — de-giornalistizzato alla radice, pur nel suo sapere in qualche modo di it-pop — su come scrivere il pezzo dell'estate in un mondo parallelo in cui per farlo non devi per forza ammiccare agli stessi a cui hai venduto il culo. C'è del gin-tonic invece del mojito o dello spritz, c'è l'acqua della cala di Podrače al posto dello stagno di Riccione, le polaroid contro i selfie, fascisti e filistei senza aquile reali.
Insomma, c'è tutto quello che serve, ancora una volta, per non rischiare nemmeno per sbaglio di fare completamente sold-out.
Bougainville
Erzulie
Archetipi antichi dentro brillanti fascinazioni di house industriale
Non c'è bisogno di essere un vecchio raver che c'aveva visto giusto a metà anni '90 per percepire la penosa compiacenza di buona parte delle musica elettronica odierna. Sia chiaro, non sono certo stati un 4/4 o una cassa dritta ad ammazzarci, quanto piuttosto la perdita graduale di una qualunque voglia di scoperta, una lunga dormita sui comodi allori del prossimo "su le mani". Il popolo ha parlato e — visto che le brioche costavano troppo e il pane ancor di più — gli abbiamo dato il copia/incolla, senza troppi rimorsi.
È un dato di fatto, non il lamento bacucco di qualche nostalgico di infinite nottate berlinesi o del senso di possibilità ad ampio spettro che aleggiava nell'eco di un'UK-techno di fine millennio, quando — per un certo periodo — sembrava aver codificato l'inesorabile avanzamento dell'electro trasversalmente agli altri generi musicali in una miriade di strutture ritmiche particolari.
Per farla breve, nessuno nega che la musica dance sia un sottoprodotto di un generico concetto di lifestyle, la colonna sonora di un intrattenimento. Ma questo non vuol dire che debba per forza essere stupida.
Lo sa bene Luigi Mastandrea — una laurea in filosofia e un diploma in conservatorio — producer pugliese trapiantato a Bologna, se guardiamo il certificato di residenza, ma ben oltre quel che resta della Cortina di Ferro o di una Manica pre-Brexit, in termini di beat & mood.
Una roba così poteva stare nel catalogo Warp e invece esce per Biodiversità Records. Visto il nome dell'etichetta fiorentina, probabilmente non un caso. Perché Bougainville è il digitale che chiude fuori l'analogico dalla porta mentre quello gli rientra dalla finestra e gli fa pure prendere uno spavento quando gli dà una pacca sul culo. La terra di nessuno — e quindi, per contro, di tutti — in cui si incontrano stilemi classici e idee futuribili con pezzi di industrial, house, hardcore e softcore. La parte intelligent che torna protagonista dell'IDM.
È una nuova forma di vita floreale che corrode una cassetta techno. La pianta viva e vegeta che occupa l'esoscheletro solo apparentemente avvizzito di un panorama italiano che, al riguardo, ha da dire molto di più — e molto meglio — di tanti ben più noti troiai, buoni per gli aperitivi hipster.
Wynona Oak
Lonely Hearts Club
Preparatevi: è arrivata la Lana Del Rey dell'electro-pop
Dagli ABBA agli Ace of Base, dai Roxette a Robyn, dai Knife agli Europe. Per non parlare di un certo Max Martin, responsabile di più di venti pezzi che, dal 2000 a oggi, sono finiti al n.1 di Billboard. Quasi sempre un po' tamarro, costantemente di successo — perché, storicamente, il miglior pop europeo è spesso arrivato dalla Svezia? Che un innato talento per il ritornello-killer sia un'eredità genetica che i vichinghi si sono passati di generazione in generazione insieme ai capelli biondi e gli occhi azzurri? Non credo.
La risposta seria, in realtà, c'è, ma necessiterebbe un saggio per essere approfondita a dovere. Tocca svariati punti caldi, tra cui tutta una serie di politiche pubbliche volte a carezzare il pelo di una next generation di pop-star fatte in casa e una naturale inclinazione culturale a essere sempre sul pezzo per poterci dare oggi il nostro pop quotidiano in ogni sua forma e pure a un prezzo che ci pare un vero affare. Cosa, quest'ultima, drammaticamente provata dal gonfiore delle vostre borse quando uscite dall'IKEA o da H&M.
Prendete Johanna Ekmark. Nasce a Sollerön (uno paesino sperduto su un'isola sperduta in mezzo a un lago sperduto al centro della sperduta Scandinavia selvaggia), si diploma in una scuola così e, appena diciottenne, si trasferisce a Stoccolma dove inizia a farsi chiamare con un nome che a lei probabilmente sembra più fico ma che in realtà pare uscito da Beverly Hills 90210 — Winona Oak, nel giro di un anno, si intrufola in un singolo di What So Not, compare in un pezzo del secondo album dei Chainsmokers e fa una cover delle Haim. Poi venitemi a dire che gli svedesi non sanno penetrare il mercato come un grissino nel tonno Rio Mare. L'Atlantic è dello stesso parere e la mette subito sotto contratto per un EP di debutto. Della serie: gavetta, questa sconosciuta.
Lonely Heart Club è l'ultimo singolo tratto da Closure e la vede — scazzata e bellissima come l'incrocio tra Miley Cyrus e un Mio Mini Pony — indugiare su una melodia caramellosa capace di rimettere in sesto qualunque cuore spezzato, nonostante sia truccata come un template di MySpace del 2005. Senza Comic Sans, però. Insomma, pop svedese di altissimo livello, che sa giocare con un'estetica rétro anni '80 mentre prende l'attualità delusa di ben noti amori allo Xanax e, dall'altra parte dell'oceano, la porta fino alla copertina di Cioè, senza per forza farti sentire un undicenne.
Non serve un genio per capire che con questa ragazza c'è da farci sul serio una barcata di soldi.
Flamingo
Rose
Confinati e liberi
È successo a molti, quest'anno, e non potevano certo saperlo. Che l'uscita del loro album sarebbe coincisa con l'entrata in scena di quella che poi si è rivelata la parola più (ab)usata degli ultimi mesi: lockdown. Per dire, chissà come l'ha presa Lavinia Siardi, che — dopo svariato tempo passato a girovagare tra Milano, la Norvegia e il Giappone — si è trovata a rivalutare le gioie e i dolori di un pit stop forzato nelle natie terre friulane, in compagnia della famiglia al completo (gatta compresa).
E pensare che — parole sue — «doveva essere il disco della liberazione». Fa ridere amaramente, letta così, ma non è detto che tutto sia perduto, in questo senso. Alla fine "liberazione" ha mille significati, altrettante sfumature e può manifestarsi nelle maniere, nei tempi e nei luoghi più inaspettati. Anche dentro casa, nel periodo più nero di questi Duemila. Non è un caso infatti che komorebi sia un'espressione giapponese che — come tutte le cose filtrate da barriere linguistiche e culturali — può voler dire tutto e nulla, e quindi venir buona per tutte le stagioni.
"Luce che filtra tra gli alberi" pare sia la traduzione più plausibile, e la luce di questa Rose è quella di una ragazza con la chitarra che diventa una donna capace di scrivere canzoni con la "C" maiuscola, di una band che debutta sulla lunga distanza con la consapevolezza del veterano. Le atmosfere sono quelle dei Daughter e degli XX, la voglia di autodeterminazione quella dei Savages, ma la rabbia di fondo ha qualcosa che va più indietro nel tempo. A quegli anni Novanta che hanno lasciato il segno anche su chi era appena nato e il cui riflusso difficilmente perdona chi si è trovato nei paraggi. Certe esplosioni pop aggressive ricordano i migliori Garbage, la produzione (e la batteria) di Giacomo Carlone non avrebbe niente da invidiare a Butch Vig (a parte il budget disponibile, s'intende) e se per caso, quando i suoni si fanno distorti, vi viene da pensare a Xabier Iriondo, no, non siete impazziti — dietro le quinte c'è proprio l'ex Afterhours in carne e ossa.
The National
Never Tear Us Apart
Spegnere incendi con secchiate di malinconia
In tempi di piena paranoia da pandemia è utile ricordare — per omaggiare il catartico mestiere della vergogna o anche solo per distrarsi un attimo dagli starnuti dei vicini — che, mentre il coronavirus già bazzicava per le strade di Codogno, l'altra parte del mondo stava bruciando da un po' e da un po' noi ce ne stavamo fregando allegramente. Ma si sa, i bacilli si trasmettono per via aerea (in alcuni casi, volano proprio in prima classe), mentre un incendio che scavalca l'opportuno oceano che ci divide dal misfatto non si è mai visto. Quindi chìssene.
Sia chiaro, pragmaticamente parlando è anche giusto che ognuno pensi al proprio culo, ma forse è almeno arrivato il momento di frugarvi in tasca e fare uno di quei gesti che allegerisce le coscienze senza per forza alleggerire il portafogli: donare due lire. Promesso, niente contatto fisico, solo una transazione online sanificata per avere in cambio una compilation di altissima qualità, sempre buona per allietare eventuali quarantene e alleviare lo stress da smart-working.
Poco importa che la storia abbia sentenziato, al riguardo, un sonoro "chìssene": con dei presupposti del genere qualche chilo di scorie ad affossare l'autostima ti rimangono per forza. Ed O'Brien c'ha messo quasi trent'anni a scuotersele di dosso, ma oggi — finalmente — fa outing con una piacevolissima sorpresa, che da sola — nell'ottica di un senno di poi che grazie a Dio non arriva troppo tardi — racconta una capacità di scrittura per niente scontata e conferma il sospetto che non puoi diventare la band più importante della storia recente del rock se tutti i membri non portano il loro personale contributo alla causa.
Messa su in meno di due mesi da Julia Stone, Songs for Australia vede la partecipazione di gente come Damien Rice, Joan as Police Woman, Kurt Vile, Martha Wainwright, Sam Amidon e altri, che reintrepretano grandi classici della musica aussie.
Ai National tocca prendersi cura di Never Tear Us Apart, tratta dall'album con cui gli INXS, nel 1987, conquistarono il mondo — Kick. Il tappeto di archi sintetici dell'originale lascia il posto a un pattern di batteria programmata, mentre — nonostante l'inserimento didascalico di qualche fiato — è la chitarra che gioca orgogliosa con le note del vecchio solo di sax di Kirk Pengilly. Ma, al di là della rilettura in sé, è intrigante vedere come l'evidente distanza dei punti di partenza trovi la sua perfetta sintesi in un territorio comune: un pezzo forse anche eccessivamente mieloso per gli standard della band australiana che invece suona quasi allegro rispetto al catalogo medio del gruppo di Cincinnati.
La verità è che farebbe la sua porca figura nella tracklist di Trouble Will Find Me. E ciò dimostra un sottotesto forse ancora poco esplorato, ovvero il lato malinconico di Michael Hutchence e compagnia, che in fondo in fondo — fuori dal cono di machismo funk di I Need You Tonight — mai hanno negato di trovarsi a proprio agio all'ombra di quelle melancholia su cui i National e i loro cloni wannabe hanno poi costruito una carriera.