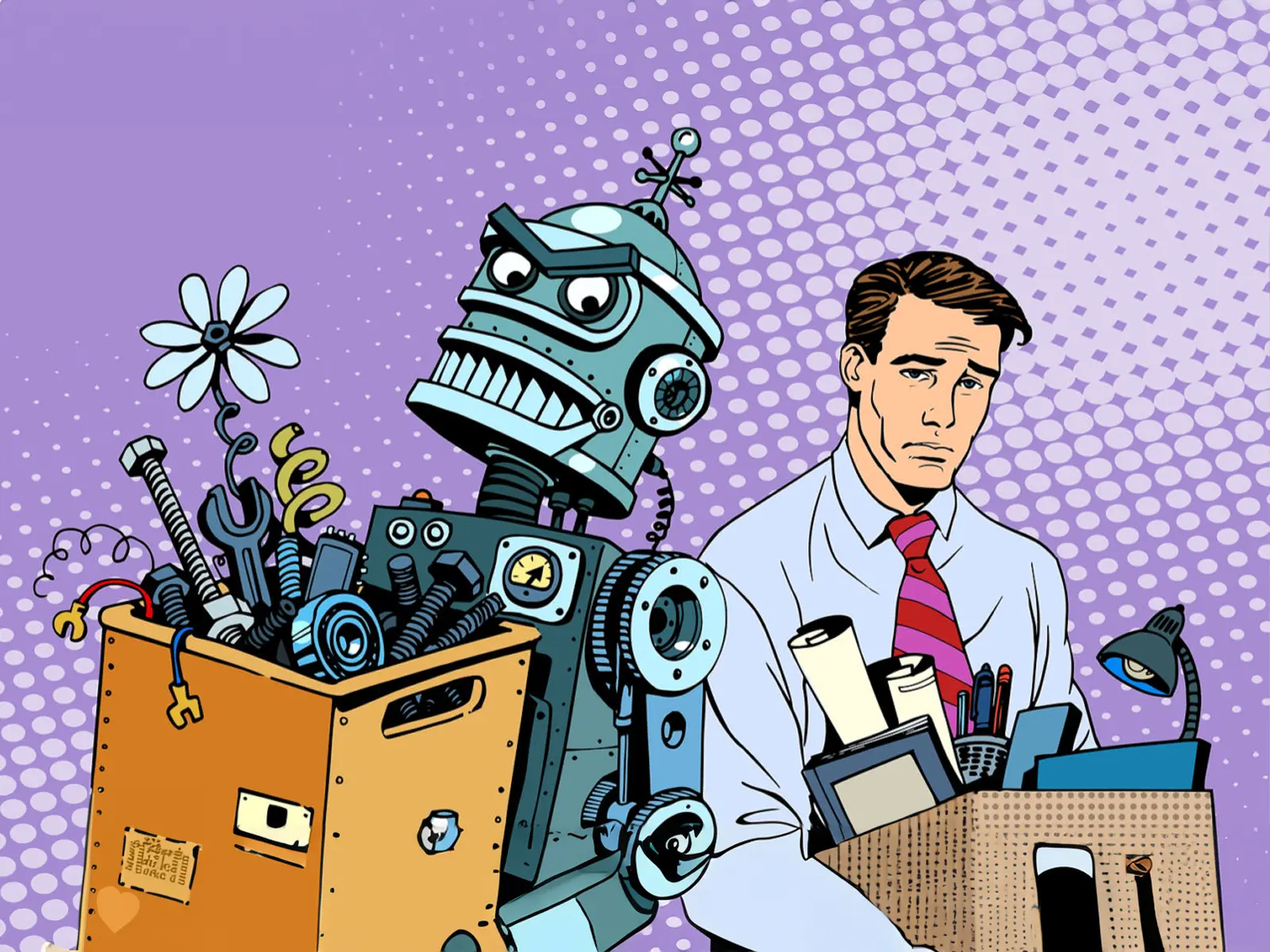
HVSR Digest #8
Eels, Soulwax, Snow Patrol, The Coral e Cabbage: cinque pezzi buoni per saltare da un ponte di primavera all'altro senza perdere l'equilibrio, come se niente fosse. Parkour!
29 Aprile 2018
The Coral
Sweet Release
Quei bravi ragazzi
I Coral una volta erano dei bravi ragazzi (per quanto si possa essere dei bravi ragazzi dopo esser cresciuti nel seminterrato del Flat Foot Sam's Pub di Hoylake — penisola di Wirral, Merseyside) con i capelli più o meno corti, che volevano suonare il rock'n'roll, quello un po' allegrotto che non puoi resistere dal battere il piedino per terra quando lo ascolti.
Oggi — a più di quindici anni di distanza — ce li ritroviamo invecchiati in maniera sapientemente trasandata (Lee Southall si è progressivamente trasformato nella controfigura di Sergio Pizzorno e gli altri sembrano i membri di una cricca di sbandati uscita da un film di Guy Ritchie) con nove album sulle spalle e un'onestissima carriera che si è sviluppata — volutamente o meno? Questa la domanda che ci ronza in testa — relativamente ai margini dello stardom. Mica poco per un gruppetto che, ai tempi del suo debutto, in molti avevano indicato tra quelli che avrebbero dovuto riportare la bandiera del britpop in alto nei cieli del resto del mondo grazie a una lunga serie di successi da classifica e quindi — così va la vita, o almeno la legge di Murphy — in realtà pareva destinato a bruciarsi via in un soffio come l'ennesimo fuoco di paglia attizzato con le pagine di NME.
Non facciamo quindi troppo gli schizzinosi e godiamoci senza impegno Sweet Release, primo singolo tratto da Move Through The Dawn (in uscita a metà Agosto), e il suo surreale — ai limiti del burlesque — video retrò in 4/3, che si candida a miglior reinterpretazione low-budget (così low-budget che la produzione — vista la recente tassa sui sacchetti di plastica nei supermercati — ha fornito all'addetto ai costumi, oltre a uno stock di tute da metalmeccanico usate, solo un misero set di buste di carta) dell'iconico lavoro fatto a suo tempo da Michel Gondry per i Daft Punk.
Girato negli ambienti della Invisible Wind Factory, nuova location inaugurata un paio di anni fa nella zona del porto di Liverpool, diretto da James Slater e coreografato da Debbie Milner, ci ricorda essenzialmente due cose: i Coral, almeno musicalmente, raramente ti sorprenderanno con qualcosa di nuovo, però quella roba che fanno da sempre la sanno fare bene sul serio, visto che — anche a questo giro — il rock'n'roll in questione è allegrotto quanto basta e il piedino — di nuovo — parte inconsulto a tenere il tempo sul pavimento, come fosse dotato di vita propria, che tu lo voglia o meno.
Eels
Bone Dry
Il massimo di ottimismo che possiamo aspettarci da un pezzo proveniente dal pianeta E
Se fosse un titolo clickbait, sarebbe "Come sopravvivere alla scomparsa di tutta la tua famiglia e trovare comunque un senso nella vita". Se fosse un hashtag, sarebbe #MyLifeIsWorseThanYours.
Se invece volessimo riassumere il tutto in maniera schematica, ridurre un complicato percorso di sfighe ai suoi soli punti salienti e raccontare una tragedia per tappe — insomma, una roba che sta a metà tra una via crucis e una presentazione powerpoint — diciamo che le cose, sul pianeta E., sono andate più o meno così: il figlio (un po' insicuro, timido e dall'aspetto piuttosto nerd a causa di un paio di occhiali da pentapartito che sarà costretto a indossare per sempre, dopo essere stato colpito da un laser durante un concerto degli Who) di un eminente fisico americano (Hugh Everett III, genio incompreso della meccanica quantistica) perde prima il padre per un attacco di cuore, poi l'amata sorella depressa che si suicida e quindi la madre a causa di un cancro ai polmoni. Per farla breve, all'alba dell'estate 2001, l'unico parente che gli è rimasto è una cara cugina, che però pensa bene di imbarcarsi come hostess sul volo 77 di American Airlines. Sì, quello che l'11 settembre si schianta sul Pentagono, subito dopo il casino delle Torri Gemelle.
E pensare che c'è ancora qualcuno che si chiede come mai le canzoni degli Eels suonino "un po' troppo tristi".
In ogni caso, Mark Oliver Everett ha costruito una carriera sul concetto di catarsi e ha passato vent'anni (e dodici dischi) a tentare di fare a pezzi la propria psiche per poi ricostruirla in musica, mantenendo sempre e comunque un invidiabile, abbacchiato, senso dell'umorismo che gli ha permesso di sopravvivere alla sua storia, a se stesso e a un sacco di altre cose tra cui — non ultima — la convinzione (molto diffusa verso la fine degli anni '90) che una barba incolta e un atteggiamento distaccato fossero sufficienti per sembrare intelligente. Oggi arriva addirittura a sbilanciarsi con dichiarazione del tipo:
The world is going nuts. But if you look for it, there is still great beauty to be found. Sometimes you don't even have to look for it. Other times you have to try to make it yourself. And then there are times you have to tear something apart to find something beautiful inside.
Il che può spiegarsi solo in due modi: o è andato in piena overdose da Novocaine for the Soul, oppure davvero, quando ogni cosa intorno a te sta crollando, l'unico modo per uscirne illesi è aspettare che la polvere si sia posata del tutto sulle rovine e solo allora cercare tra i cocci una nuova ragione per essere felice.
Ok, "felice" forse è una parola grossa, ma a quanto pare il momento di provarci è arrivato con questo ultimo album, The Deconstruction: Bone Dry è il quarto singolo e, per scaramanzia — forse a compensare l'incauto ottimismo delle parole precedenti — arriva accompagnato da un piccolo capolavoro di stop-motion a firma Sofia Astrom, che rende omaggio al maestro Tim Burton con una specie di medley tra Nightmare Before Christmas e La Sposa Cadavere, forse più inquietante di entrambi e che finisce — ovviamente — peggio.
In fin dei conti è la solita canzone degli Eels, ma va detto che gli Eels da un po' di anni non tiravano fuori una solita canzone degli Eels così. E Dio solo sa quando ci piacciono le solite canzoni degli Eels, quelle fatte bene.
Snow Patrol
Life On Earth
La vita rivista da lontano
Quando si usa la parola "iato", parlando di una band, in genere si fa riferimento a un break, una pausa di riflessione, un'interruzione dell'attività musicale per un tempo più o meno indefinito. In pratica, è un modo radical-chic di spiegare che il gruppo si è sciolto, ma già si teme una reunion. Per dire, i Tool entrano puntualmente "in iato" tra ogni disco e il successivo: così, per non far calare la tensione.
Lo iato degli Snow Patrol è durato sette anni ed è stato un po' più complicato del previsto, visto che Gary Lightbody li ha passati, nell'ordine, a:
- Continuare a sniffare cocaina.
- Continuare a bere come una spugna.
- Cercare di smettere di sniffare.
- Cercare di smettere di bere.
- Iniziare a deprimersi perché che senso ha una vita senza droga e alcol?
- Tentare di riprendersi dalla depressione senza ricominciare ubriacarsi e a tirar su strisce di svariati centimetri di lunghezza.
- Provare a buttar giù qualche idea per un album nonostante il conseguente blocco dello scrittore, dovuto all'elevato numero di neuroni bruciati.
Poi è andata che è tutto bene quel che finisce bene, nel senso che Wildness uscirà a fine Maggio e il (non più) ragazzo sembra stare decisamente meglio, anche se ha capito che questo nostro pianeta non è esattamente il posto più adatto per prendersi cura del proprio equilibrio: troppi milioni di copie venduti, troppi dischi di platino, troppe nomination a Grammy, Brit Awards e Mercury Prize. Troppe tentazioni, insomma: o hai l'esperienza di Chris Martin in materia o rischi di sbroccare sul serio. Allora meglio un ritiro ascetico nello spazio, a guardare la Terra da lontano crogiolandosi in dubbi amletici del tipo:
It shouldn't need to be so fucking hard, this life on Earth.
Girato all'interno dell'European Space Agency in Olanda e dato in anteprima all'astronauta inglese Tim Peake invece che a NME, questo nuovo singolo ti lavora in testa tuo malgrado, come un tarlo (e come tutte le migliori canzoni degli Snow Patrol), provando a battere una strada già tentata in Italia da Fabio Fazio con Samantha Cristoforetti: prendere le missioni in orbita e riportarle a un livello di mainstream paragonabile quello dei tempi d'oro della corsa allo spazio.
Battute a parte, la scia di suicidi eccellenti che il gran carrozzone del music business ci ha lasciato in dote in questi ultimi anni ci ha insegnato che il successo non sempre va a braccetto con la felicità e quindi, per una volta, forse conviene lasciar perdere l'effettivo valore del pezzo e rallegrarci semplicemente che il suo autore abbia (ri)trovato la forza per portarlo alla luce.
Cabbage
Arms of Pleonexia
Piacevoli sorprese a scatola (quasi) chiusa
Ci sono dischi che compri senza sapere bene perché: mai letta nemmeno mezza recensione, mai sentito parlare dell'artista, mai fidato del concetto filosofico di "scatola chiusa" che — per esperienza, una volta aperta — sai benissimo riserva più frequentemente brutte fregature che piacevoli sorprese. Eppure.
In genere, può succedere per tre stupidi motivi: ti colpisce il titolo dell'album, ti incuriosisce il nome della band, rimani ipnotizzato dal genio (qualunque significato vuoi dare alla parola) dell'artwork di copertina. In questo senso, quello dei Cabbage è un caso di studio ideale, visto che condensa la triade di cui sopra in un unico oggetto del desiderio. Nihilistic Glamour Shots è infatti il perfetto "acchiappa-indecisi" da scaffale, ovvero: come resistere al fascino trash di un titolo così ammiccante (diciamo un po' alla dEUS), associato da un lato a una cover orrenda che mostra le sagome di alcune losche figure riunite ai piedi di una croce rovesciata (sembra uno scherzo dei Godspeed You! Black Emperor) e dall'altro a un gruppo che ha deciso di essere ricordato dai posteri con un appellativo da reparto frutta e verdura?
Anzi peggio, perché se per caso scorri velocemente la tracklist, ogni minima remora rimasta scompare davvero: pezzi come Preach to the Converted, Molotov Alcopop, Postmodernist Caligula, Subhuman 2.0, Obligatory Castration — e prima ancora questo singolo, Arms of Pleonexia, sarcasticamente dedicata alle cravatte sedute al tavolo dell'International Conference on the Arms Trade e accompagnata da un video, girato dal vecchio collaboratore Dom Foster, che porta il film muto degli anni '20 nell'arena del rock, senza però rinunciare a un drammatico finale shakespeariano — mostrano una maestria con le parole così brillante che meriterebbe l'acquisto ancor prima dell'ascolto, il "credere per provare" una volta tanto al posto del "provare per credere". Anche fossero suite per clavicembalo stonato.
Poi scopri che questo è il debutto di cinque ragazzi di una prolificità snervante, ma che hanno deciso di prendersela così comoda da uscire con il loro primo disco in occasione del loro secondo disco (il precedente Young, Dumb & Full Of… era semplicemente l'accorpamento in un unico vinile dei loro vecchi tre EP in occasione dello scorso Record Store Day). Scopri che è tutt'altro che gente buttata allo sbaraglio nel carnaio delle next big thing, ma anzi una band con più di 200 concerti all'attivo. Scopri che un punk moderno, sufficientemente post e adeguatamente sguaiato può andare deliziosamente a braccetto sia con una denuncia sociale di stampo quasi marxista, buttata là con aria minacciosa e senza peli sulla lingua, che con un perverso humor nero tipicamente britannico.
Scopri, insomma, che, contro ogni previsione, hai avuto culo. Che la fortuna, se proprio non arriva ad aiutare gli audaci, almeno ha un po' di compassione per gli incoscienti. Che per quest'anno, il bonus "acquisti a caso" te lo sei giocato bene.
Soulwax
Essential Four
Se non l'ha ancora fatto nessuno lo facciamo noi
C'è gente che proprio non ce la fa a star ferma. Gente che se rimane pochi attimi con le mani in mano va fuori di cervello. Gente che non concepisce proprio quanto può essere terapeutica una serata immobili sul divano con il gatto che ti ronfa beato sulle ginocchia.
I fratelli Dewaele sono due di questi. Anzi, peggio. I fratelli Dewaele non solo son gente che proprio non ce la fa a star ferma, ma son pure gente che non ce la fa occupare il tempo in cui non ce la fa a star ferma con cose, non dico banali, ma nemmeno normali. Sempre alla ricerca di nuove idee bislacche da mettere in pratica e obiettivi più sfidanti verso cui spingersi, la cosa difficile da mandar giù — brutta bestia, l'invidia — è che, immancabilmente, prima li trovano e poi li raggiungono con malcelata scioltezza.
Solo per limitarci agli ultimi due anni e alle uscite ufficiali a firma Soulwax, hanno prima composto la colonna sonora di un film indie belga spacciandola per una compilation di gruppetti sconosciuti quando in realtà erano sempre loro a suonare ogni canzone qualunque fosse il genere musicale sposato dall'ipotetica fake band associata, poi fatto uscire un disco di musica elettronica registrato in unico take dopo averlo composto e provato in tour con un set di synth analogici da fare invidia ai nipoti di Robert Moog opportunamente integrato con tre batterie dotate di doppia cassa (due delle quali suonate da Igor Cavalera e consorte) e infine curato il loro Essential Mix per BBC1.
Se vi sfugge cosa ci sia di strano in quest'ultima cosa, è perché ho tralasciato un particolare non trascurabile. In risposta alla richiesta della radio britannica infatti, i due non si sono nemmeno sognati — come qualunque persona sana di mente avrebbe fatto — di preparare un mixato di pezzi altrui (o comunque già esistenti), ma si sono chiusi in studio per una settimana e hanno tirato fuori un'ora abbondante di musica inedita, tutta ispirata alla parola "essential", facendo sì che i ragazzi dell'emittente si ritrovassero on air l'anteprima di un nuovo album senza nemmeno essere stati avvertiti con un minimo di preavviso.
Fosse sempre facile lavorare nello splendido mondo dell'FM!
Comunque, il 22 giungno finalmente il tutto verrà pubblicato come Dio comanda e questa è la prima traccia singola che anticipa il resto. Si chiama Essential Four, ma avrebbe potuto essere Essential Two, o Essential Nine o Essential [ aggiungi un numero a caso da 1 a 12 ]: la differenza sarebbe stata minima. Quello che conta è il concetto a monte che — tanto per cambiare — fa sì che i Soulwax spuntino l'ennesima casella dalla lista delle cose che nessun altro aveva mai fatto fino ad oggi.