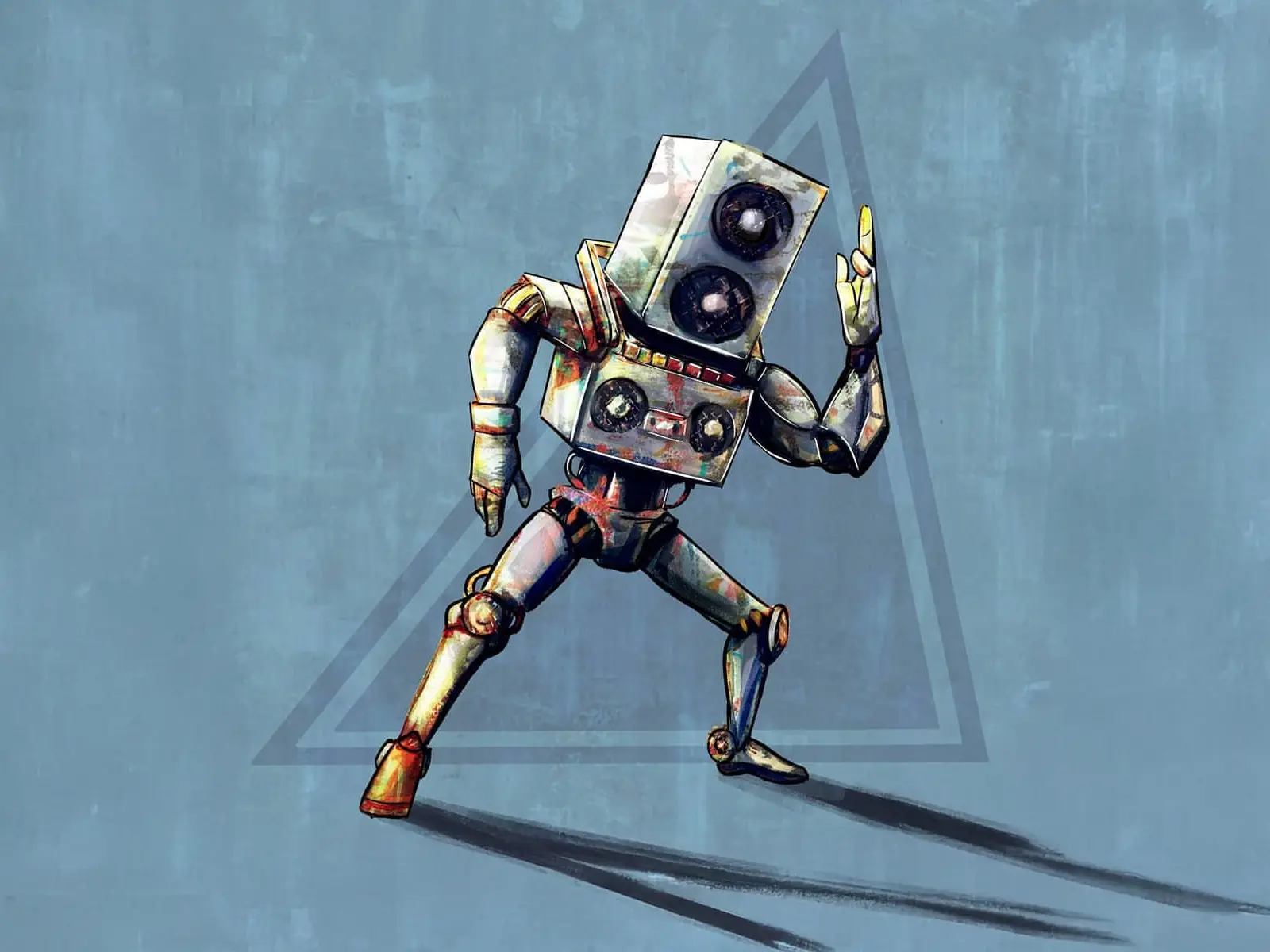
HVSR Digest #23
Birthh, i DIIV, i Telefon Tel Aviv, Cate Le Bon e i Clipping: cinque pezzi buoni per salutare l'estate, ma anche no, dato che le mezze stagioni, ultimamente, chi le ha viste?
30 Ottobre 2019
Birthh
Supermarkets
Il talento vero non ha bisogno di guardare all'erba del vicino
Avere vent'anni e la voce di Elena Tonra è meno semplice di quel che si potrebbe pensare a una prima analisi superficiale. Nel senso, finché parli non ci sono particolari problemi, soprattutto alla luce del fatto che parli in italiano. Se però di mestiere vuoi fare la musicista e per di più canti (in inglese) allora le cose si fanno più complicate.
Se a questo ci aggiungi che — a nemmeno vent'anni — hai anche il gusto per gli intrecci tra linee di chitarra e loop elettronici di Romy Madley Croft e James Thomas Smith e un'urgenza di sperimentazione che a tratti ricorda quella degli Alt-J quando avevano poco più di vent'anni, allora preparati: inizieranno a dire che sei cresciuta a pane e Daughter, che queste cose le avevano già fatte gli XX, che hai ascoltato troppo James Blake.
Alice Bisi (nemmeno vent'anni, la voce di Elena Tonra, la capacità compositiva degli XX e tutta l'urgenza espressiva della sua età) queste cose le avrà sentite e risentite fino alla nausea, soprattutto dopo aver debuttato con un piccolo grande capolavoro che con gli ingombranti nomi di cui sopra se la giocava ad armi pari e senza il minimo timore reverenziale. Eppure non si scompone e prosegue per la sua strada forte dell'unica cosa che conta: il suo immenso talento. Talento che sa essere — come dimostra questo nuovo singolo, che starebbe bene in mano agli Any Other — malinconico e giocoso allo stesso tempo, mischiare sapientemente pop, folk, soft jazz e indietronica, e fare ancora un altro passo oltre una maturità già pienamente acquisita.
Perché uscire dalla tua comfort zone per raccontare l'immaginario rassicurante della routine quotidiana significa essere a proprio agio con l'arte del paradosso. E anche venire a patti con il fatto che «le persone sono solo persone / non sanno cosa stanno cercando» può sembrare scontato, ma succede solo quando sei diventata adulta sul serio.
DIIV
Blankenship
Verso il lato oscuro del confessionale: andata e ritorno
I DIIV sono una roba che ha rischiato di finir male. E, come tutte le robe che soltanto rischiano di finir male ma poi si tirano su dagli impicci sulle proprie gambe, ora stanno in piedi più convinti di prima. Quel che non ti ammazza ti fortifica, no? O, male che vada, ingrassa.
Un debutto acclamato all'unanimità e un seguito che ne ha raccolto i pezzi nel modo migliore che si potesse pensare. Nel mezzo, tre anni di documentato e dichiarato delirio, costantemente sull'orlo di mandare in vacca una delle realtà più promettenti degli ultimi dieci anni, senza (ri)passare dal via.
In ordine crescente di pericolosità: scazzi con gli altri membri della band, dipendenze pesanti da droghe di svariate composizioni chimiche, una relazione tutta pepe con Sky Ferreira. Se ne esci pulito e relativamente profumato, poi non può che essere tutta discesa. Chiedete conferma a Zachary Cole Smith.
Il terzo capitolo della questione si chiama Deceiver e ha appena visto la luce. Blankenship ha solo il compito di farci venire l'acquolina in bocca e ci riesce con la facilità con cui si ruberebbero le caramelle a un bambino. Un bambino cieco, per la precisione. Lo fa scegliendo un'alchimia che rasenta la perfezione: prende ingredienti di cui conosciamo benissimo il sapore (il noise di scuola Sonic Youth, una certa dark-wave che richiama i Cure, uno shoegaze sperimentale che va a pisciare nel giardino dei TOY) e li accosta con un garbo disarmante. Poi ci aggiunge un paio di stacchi inaspettati — che sanno più di Deafheaven o Neurosis che di tutto l'ambaradan di cui sopra — ed è praticamente fatta.
Abbiamo di fronte un progetto che cresce di disco in disco con una pendenza da maglia a pois. Di questo passo, è complicato immaginare dove possa arrivare.
Telefon Tel
A Younger Version of Myself
Sogni ricorrenti da giocare al lutto
Dopo una cosa del genere è difficile andare avanti. Figuriamoci ricominciare. Molti non ci riescono (penso con rammarico agli Offlaga Disco Pax). Quelli che ne sono capaci, lo fanno sotto un altro nome (diciamo i New Order, ma la lista è lunga), come a chiudere rispettosamente un capitolo. Per una band mediamente numerosa forse è più semplice: la percentuale che si perde è inferiore rispetto al tutto. In due è davvero dura: significa restare fermi a metà di un racconto, in una simbiosi interrotta che non promette nulla di buono.
Joshua Eustis ci ha messo dieci anni a elaborare il lutto per la tragica scomparsa di Charlie Cooper. O almeno a trovare la forza di rimettersi in pista. Torna oggi con Dreams Are Not Enough e decide di farlo ancora dietro al moniker Telefon Tel Aviv, marchio di fabbrica che all'inizio di questi cazzo di anni Zero ha contribuito non poco a plasmare un certo tipo di elettronica moderna, diversa. O, se non altro, a tenerla al riparo dal crescente rumore che avrebbe fatto la bolla dell'EDM una volta esplosa.
Più che un album, la presa di coscienza di una condizione irreversibile, ben descritta dall'immagine che si compone mettendo i titoli delle nove tracce uno dietro l'altro:
I dream of it often: a younger version of myself, standing at the bottom of the ocean. Arms aloft, mouth agape, eyes glaring, not seeing, not breathing, still as stone in a watery fane.
Perché quando si tratta di colmare un'assenza, i sogni non sono mai abbastanza e allora l'unico modo è imparare a fraternizzare con quel senso di vuoto, parlare la sua stessa lingua asciugando le canzoni stesse ed eliminando dai mix finali tutti gli elementi superflui e non necessari alla guarigione, finendo così per incorniciare la mancanza in un'istantanea che contiene sia quello che non c'è che il poco che è rimasto.
Cate Le Bon
Company in My Back
Cover originali: suona come un ossimoro, e invece
Chiamatela congiunzione astrale, chiamatela sovraesposizione mediatica a orologeria, chiamatela campagna di marketing a tappeto. Non fa differenza. La cosa certa è che — e mai ci stancheremo di ringraziare il cielo — in questo periodo Jeff Tweedy & Co. sono sempre tra i maroni.
Non solo due album solisti nel giro di sei mesi e poi quello (appena uscito) con la band al completo, ma anche un tributo a Yankee Hotel Foxtrot e adesso Wilco-vered, una selezione di cover che vede tra gli interpreti gente del calibro di Sharon Van Etten, Low, Kurt Vile e Parquet Courts — per citarne un paio a caso — e compare come esclusivo allegato al numero di novembre di Uncut Magazine. Così, giusto per riprendere quella buona, vecchia abitudine (scomparsa ancor prima dell'estinzione delle riviste di carta) dei CD in regalo con i giornali.
Cate Le Bon — anche lei di nuovo in pista quest'anno con il suo nuovo lavoro — visto che aveva già il microfono in mano, si prende Company in My Back e la ribalta in una versione caratterizzata da colpetti di dissonanza pop che adagiano la traccia di A Ghost Is Born perfettamente sulle sue corde.
In tempi come questi — in cui non ci sono più non solo le mezze stagioni ma nemmeno mezze misure che stiano a metà tra un analfabetismo acritico e credulone e una diffidenza preventiva verso qualunque notizia o novità — non fa sicuramente male sottolineare un fatto non proprio scontato. Ovvero che il valore di un'uscita del genere va ben oltre la pescata a strascico nel laghetto delle cover già sentite per portare a casa un piatto fritto e rifritto, buono giusto per sbarcare la cena. Eccetto uno infatti, tutti i pezzi presenti in questa compilation sono assolutamente inediti e registrati espressamente per l'occasione.
Certo non il solo, ma sicuramente un buon motivo per approfittare — in mezzo a tutti i tutorial che ultimamente ci insegnano come cucinare con gli avanzi — di un menu così gourmet, senza rimorsi a tema dieta.
Clipping
Blood of the Fang
Il rap come se fosse fatto dai Throbbing Gristle
I Clipping una volta erano "clipping." — con la minuscola e il punto finale. Ora, stando al loro account YouTube (che riprende il titolo del loro secondo album), forse addirittura "clppng" — come se si fossero contratti in un codice fiscale. Vai a sapere: dopotutto, l'importanza del lettering delle band è inversamente proporzionale al grado di ossessività con cui ti fanno notare che lo stai sbagliando. E ai tre manipolatori californiani la cosa non sembra interessare granché.
Quel che ci tengono a ribadire è invece quanto sono bravi a fare musica che mette a disagio, roba che ti fa accelerare il battito cardiaco, serrare le mascelle e digrignare i denti laddove la lingua duole. Musica con cui non ti puoi rilassare. Non puoi leggere, non puoi guidare, non puoi stare a parlare con qualcun altro, mentre ascolti i Clipping. L'unica cosa che puoi fare è arrenderti alle potenti, brutte vibrazioni che ti inizieranno a salire su dalle palle fino a quel groppo in gola che si va ingrossando sempre più.
This Is America di Childish Gambino ha tracciato, sul terreno arido del lato visuale dell'hip-hop, una crepa da cui non si può più tornare indietro. I Clipping — fortuna o genio, non fa differenza — erano già dal lato giusto del burrone e ora non fanno che affondare il coltello nella piaga, portando la questione al livello di un saggio teorico-pratico sul concetto di orrore dalle Black Panther ai giorni nostri.
Non è un caso che, come Donald Glover, anche Daveed Diggs sia un attore prima che un rapper e che si trovi a suo agio tanto nella homepage di Netflix quanto nel sudiciume del ghetto. Solo così puoi riuscire a ridurre le 5K battute mitragliate dal testo di Blood of the Fang in un video di quattro minuti, che farebbe sorridere il Dr. House, anche se alle prese con un'operazione a cuore aperto su un kalashnikov.
Come prevedibile, c'è tanto sangue. Ma vale ogni goccia.