
L'insostenibile pesantezza dell'essere i Radiohead
La storia di Kid A, ovvero il resoconto di un esperimento fallito, almeno nelle intenzioni. Anzi, no. O comunque, per fortuna.
20 Luglio 2020
Il 9 ottobre del 2000 è un lunedì uggioso sulla East Coast. Lo skyline di New York continua a inciampare nelle punte delle Torri Gemelle, beatamente ignaro che sarà così ancora per poco. Dalla parte opposta invece — a tremila miglia e sei ore di volo di distanza — il sole splende sopra i boulevard hollywoodiani e, nel bagno degli uomini all'ultimo piano del Capitol Building a Los Angeles, un tizio si sta sciacquando la faccia. Le braccia tese sui bordi del lavandino, cerca di tenere al minimo il battito, sperando che il respiro non ceda. Ha 'espressione di chi l'ha scampata bella, quella del giocatore di poker all'ultima spiaggia che ha bluffato e si è portato via tutta la posta. Sa che il peggio è passato, che quella cosa che ha avallato sottobanco nell'ultimo mese e che era iniziata come un colpo di stato si è appena trasformata in un colpo di genio. È il momento di rimettersi in sesto, stringere di nuovo il nodo della cravatta, rendersi presentabile e tornare in sala riunioni a cambiare tutte le fiches che improvvisamente si ritrova in tasca.
Quell'uomo si chiama Rob Gordon, di mestiere fa il vicepresidente marketing della CMG e ha appena visto un'anteprima dei report ufficiali di vendita relativi all'ultima settimana: Kid A ha debuttato direttamente al primo posto in classifica sia in UK che negli USA. Ed è ancora lassù in cima.
In poche parole: un bel po' di consumatori soddisfatti, soprattutto considerando il fatto che il prodotto in questione era stato specificatamente progettato per non soddisfare il consumatore.

Quello che i report non dicono
Non è un coglione, Rob Gordon, anzi. Sta nel giro giusto da un po', ha fatto carriera per meriti propri e senza troppi calci nel culo, ne ha viste (e soprattutto sentite) di cotte e di crude e non è certo il tipo che va in ansia per una campagna promozionale. Sa che a cose normali non ci sarebbe da essere stupiti. Dopotutto, tre anni prima, OK Computer era stato un successo planetario e l'attesa per il suo seguito era ormai già salita alle stelle. Ma ci sono cose che un report di vendite non può confessare.
È il 9 ottobre del 2000 — questo c'è scritto sul foglio, in alto a destra. Kid A ha debuttato direttamente al primo posto in classifica sia in UK che negli USA ed è ancora lassù in cima — la riga è stata accuratamente sottolineata con l'evidenziatore giallo dall'assistente. Fin qui tutto bene, o comunque dentro ipotetici, ragionevolmente ottimistici, standard.
Quello che il report non mette in luce — e che Gordon invece conosce benissimo — sono certi dati. I dati di fatto innanzitutto: lassù in cima ci è arrivato senza il supporto delle radio, senza hit, senza singoli, senza video in heavy rotation sulle TV internazionali. Ma soprattutto altri dati mai rivelati fino ad allora, ufficiosi anche se verosimili con poco margine di errore: si stima che quasi l'80% dei potenziali (ora confermati) acquirenti avessero già l'intero disco salvato in mp3 sui propri hard disk da almeno una ventina di giorni.
Pirateria, portami via.

Una serie di difficoltà
L'ha ancora bene impressa nelle orecchie, Rob Gordon, la prima volta che ha ascoltato le dieci tracce che la band aveva selezionato come tracklist definitiva del disco: cinquanta minuti scarsi. Cinquanta minuti che tutti i cervelloni dell'etichetta avevano concordato nel definire "difficili".
Non è un coglione, Rob Gordon, anzi. Sta nel giro giusto da un po', ne ha sentite di cotte e di crude e sa benissimo che quando dieci persone incravattate intorno a un tavolo marchiano un album come difficile, stanno banalmente rifugiandosi in un esercizio imparato nell'ultimo master di buone maniere: si chiama eufemismo e probabilmente faceva parte del modulo di due ore "La prima volta, mai sbilanciarsi troppo". "Difficile" è quel disco che diventa "un azzardo" quando il tuo superiore ti chiede un parere più diretto, si trasforma in "una roba inascoltabile" nei commenti con i colleghi davanti alla macchinetta del caffè, per sfondare infine la frontiera della sincerità spietata di fronte alla terza birra al bancone di un pub, dove finalmente ci si lascia sfuggire le tre paroline magiche: "un suicidio commerciale". Per di più arrivato con quasi un anno di ritardo.
Ma quest'ultimo — le aspettative del management in termini di tempistiche — è un dettaglio di poca importanza, al momento. È vero che i capoccioni della EMI sarebbero stati lietissimi di avere il quarto album dei Radiohead nelle vetrine dei negozi in tempo per il Natale 1999, ma al riguardo il VP li aveva già convinti a rinunciare all'idea. L'amara esperienza dei due dischi precedenti suggeriva che la cosa migliore era non mettere scadenze rigide ai cinque di Oxford. Quello che il management non sa — e che Gordon invece conosce benissimo — è che la band a questo giro ha dato dimostrazione di poter andare in corto circuito anche senza deadline. Ma tutto è bene quel che finisce bene, no?

Un déjà-vu senza ostetrica al capezzale del rock
Perché, per una volta sul serio, dire che "è stato un parto" non è un'esagerazione né un paragone azzardato. Nel dettaglio, la nascita di Kid A si porta appresso tutte le doglie che madre natura deve soffrire ogni volta che apre le gambe per dare alla luce una galassia di medio-grandi dimensioni. A volerla far breve, le vicissitudini sono più o meno note anche ai fan meno attenti e possono essere riassunte in una raccolta di fantastiche favolette a tema "costipazione artistica": quattro tentativi in quattro diversi studi di registrazione sparsi per l'Europa (Parigi, Copenhagen, Batsford Park, Sutton Courtenay), una lista infinita di sessioni abortite, una lavagnetta con più di cinquanta titoli abbozzati che non sanno più dove andare a parare, blocchi dello scrittore risolti tirando idee a caso fuori (nel vero senso della parola) da un cilindro, scazzi reciproci ben oltre l'orlo della crisi di nervi di almodovariana memoria, affermati musicisti che ogni due per tre si guardano smarriti chiedendosi cosa dovrebbero fare, scenari apocalittici nascosti dietro ogni angolo.
Insomma, una narrazione già vista e sentita in innumerevoli occasioni nel corso della vita del rock, ma peggio, dato il contesto. Nel senso che — proprio in termini di cicli vitali a cui il genere stesso ci ha ormai abituato — la fine degli anni '90 è uno dei periodi in cui sembra buttare veramente in vacca. La cifra tonda dei 2000 aspetta all'orizzonte promettendo chissà quali cambiamenti, ma l'industria musicale ci arriva con il torcicollo, dopo un decennio in cui la ribalta è stata in mano a roba che — mai quanto in precedenza — ha puntato forte (e quasi tutto) sul passato. Il cosiddetto grunge che ripescava i riffoni lenti dei Seventies per portare le camicie di flanella su Vogue. Il doppio gioco del britpop che provava a sdoganare una restaurazione caramellata («se non hanno più pasticche, che rimangino gli Smiths») dopo aver voyeuristicamente rosicato a lungo mentre la famosa rave culture, i localacci di Madchester e la Bristol trip-hop si facevano la perfida Albione in svariate posizioni. Il nuovo (si fa per dire) punk melodico Californiano che teneva i Beach Boys e i Bad Brains in precario equilibrio sulla stessa tavola da surf mentre si metteva in tasca non poche milionate di copie.
Tutti fenomeni — se non proprio studiati a tavolino fin dall'inizio — in cui le migliori menti markettare del mainstream si erano gettate a capofitto per una gigantesca operazione di riciclo a suon di dollari. Tagliando corto, questo lo schema: le multinazionali delle sette note riempiono le loro valigette di spartiti teoricamente nati per essere colonne sonore di rivoluzioni controculturali, mischiano il mazzo e li ributtano sul mercato — spesso volutamente, abilmente e completamente fuori contesto — per vendere CD, magliette e skate serigrafati.
Un esempio a caso: la sfilata a tema luxury grunge — a tutti gli effetti un ossimoro — che costerà a Marc Jacobs il licenziamento da Perry Ellis, ma al tempo stesso rappresenterà il trampolino di lancio per la sua futura carriera.
Così, dopo dieci anni di questa sorta, il normale ciclo della critica vuole che torni in auge la mozione dei compagni più disfattisti, ovvero quelli particolarmente bravi a recitare requiem a tema "il rock è destinato a estinguersi". E — a loro parziale discolpa — va detto che, se due indizi fanno una prova, i sintomi ci sono tutti: il corrispettivo del paniere ISTAT d'oltremanica contiene per la prima volta più giradischi che chitarre, i palinsesti di MTV iniziano a preferire Hey Boy Hey Girl dei Chemical Brothers rispetto a Pink degli Aerosmith, le rockoteche (termine, grazie a Dio, caduto presto in disuso) suonano The Fat of the Land dei Prodigy dalla prima all'ultima traccia, e poi da capo. Chi legge (ancor prima di chi è costretto a scriverne) si imbatte sempre più spesso nel termine post-rock che — non ancora diventato simbolo di sfiga cosmica rigorosamente recitata senza parole e con gli occhi bassi — può al momento significare tutto e nulla, ma sicuramente presuppone che attorno al rock (se non addirittura del rock stesso) sia stata fatta terra bruciata.
Riassumendo, siamo nell'autunno del '99 e tutti i trend-forecaster sono pronti a scommettere su una collezione primavera/estate all'insegna di variazioni sul tema attorno a un'unica regola: se c'è una freccia che indica dove sono conservati i resti del rock, scappate a gambe levate nella direzione opposta.

Questo, per intendersi, il terriccio marcio in cui dovrebbe germogliare Kid A. Questa la superficie inaridita che non può far altro se non reagire con una crepa degna della migliore tettonica a zolle applicata all'essere umano: la solita spaccatura in cui nessuno cade dentro, ma rispetto alla quale tutti sanno scegliere da che parte stare. Da un lato il disco terminale che sancisce la triste morte del rock tramite la fine indegna della rock band che non ha avuto il coraggio di provare a salvarlo, dall'altro l'album con cui, dopo eoni di agonia, il rock finalmente si fa da parte — consapevolmente e in pace — per lasciare spazio a un non ben definito futuro.
Punti di vista drastici, ma soprattutto clamorosamente sbagliati entrambi. Perché, come capita non di rado, le due fazioni che stanno ai bordi opposti di una trincea sono quelle che hanno finito per prendere due granchi diversi, ma ugualmente enormi. Se vuoi trovare il senso di una verità devi andare a vedere nel fondo del baratro — diceva il saggio. Quello che morì sepolto vivo.
L'importante è essere d'accordo
Thom Yorke, come al solito, del contesto se ne frega (o finge di):
Ci sono un sacco di cose tipicamente intese come "rock" che rimangono ancora valide. Tipo sballarsi con le droghe per ragioni creative invece che di semplice apparenza o stile di vita. O dedicare tutta la propria esistenza alla musica. Se si rimane così, ad alto livello, per definire il concetto di "rock", ok — perfetto. Per tutto il resto, sinceramente credo sia ipocrita pensare al cammino che ormai abbiamo intrapreso come una qualche sorta di "rock music".
Dopotutto, il tipo lo conoscete: uno dei pochi così presenti e sfuggenti allo stesso tempo da riuscire a usare la prima persona come cartonato dietro cui nascondersi e un egocentrismo forzato come io narrante per confondere le acque.
Il capodanno del '98 è stato uno dei momenti peggiori della mia vita. Mi sembrava di essere sul punto di impazzire. Ogni volta che prendevo in mano la chitarra mi venivano i brividi. Iniziavo a scrivere una canzone, mi fermavo dopo poche battute e subito la nascondevo nel cassetto. La ritiravo fuori, ci davo un'occhiata e poi la stracciavo, la facevo a pezzi. Stavo sprofondando nella depressione. Era sempre peggio. Non ne potevo più della melodia. Volevo ritmo. Tutte le melodie mi mettevano in difficoltà.
A testimonianza di quale unità di intenti e di visione ci sia nell'aria quando il gruppo inizia a mettere la testa sulla scrittura dei nuovi pezzi, basta confrontare queste parole con quelle di Ed O'Brien:
La mia idea prevedeva un ritorno a canzoni pop semplici, brevi, ma ben arrangiate. Ero stanco di tutte quelle analogie prog-rock.
Gli altri stanno nel mezzo, ma ognuno in un posto diverso dall'altro. Per dire, di sicuro uno come Jonny Greenwood non ha riserve rispetto a spingere verso la sperimentazione o la musica elettronica, ma nemmeno lui — e questa, forse, è l'unica cosa su cui tutti concordano — vuole cambiare per il solo gusto di farlo, in uno sconfortato e sconfortante tentativo di apparire per forza moderni e genericamente avanti rimanendo nei limiti (per quanto vasti) della loro comfort zone.
D'altro canto, come detto, la posizione ufficiale della casa discografica è «la band non ha fretta, e anche noi siamo tranquilli». I retroscena si dividono invece tra chi racconta di manager disperati, chi parla di una rassegnazione ormai assodata, chi — come John Leckie, produttore di The Bends e quindi autorevole voce in capitolo — suggerisce non pochi tentativi di velata violenza psicologica:
Sono sicuro che hanno sempre addosso una pressione indescrivibile, perché sentono di dover tirar fuori un successo. Solo che adesso non si dice, ma loro lo sanno. È ovvio che non sono obbligati a fare alcunché, visto che tutte le band inglesi e americane ormai vogliono assomigliare ai Radiohead. Ma questo, paradossalmente, rende le cose ancora più complicate.
Vero in parte, ma centro del bersaglio mancato di svariati centimetri, come spiega Nigel Godrich a Zev Borow, sul numero di Spin di Novembre 2000 (corredato dal servizio fotografico in cui compare un «new and improved Thom Yorke», photoshoppato in base a più moderni modelli di bellezza secondo cui dei lineamenti facciali perfettamente simmetrici generano più fiducia nell'ascoltatore):
Thom voleva provare a fare una cosa completamente diversa. Una cosa maledettamente difficile.

Tradotto in termini meno criptici: al di là delle sollecitazioni esterne, la pressione c'era eccome, ma era di tutt'altro tipo. Lo scopo era di non produrre un successo. Anzi, nemmeno. Più precisamente, la folle idea era quella di alterare così tanto la propria cifra stilistica al punto da rendere insensate — e quindi non più applicabili — le tradizionali, codificate metriche di giudizio che valutano la definizione stessa di "successo".
In pratica, un caso di studio imperdibile per qualunque appassionato della mente umana: quello in cui non si riesce a distinguere la totale insicurezza del paziente dalla sua innata fiducia in se stesso, perché sono la stessa cosa e l'una non potrebbe esistere senza l'altra.
Desperate times call for desperate measures
Questa la frase che risuona in loop nella mente di Rob Gordon mentre guarda allibito la serie di piccoli, allucinati video di 15 secondi preparati da Stanley Donwood. Lui li chiama blip, sono una decina, non arrivano a un quarto d'ora di durata totale e, a detta della band, saranno l'unica azione promozionale prima dell'uscita del disco. Il reparto marketing della EMI scuote la testa all'unisono: non esiste che MTV mandi in onda quella roba, sostengono. Donwood li guarda con una faccia provocatoriamente angelica e chiede stupito: «Chi ha detto che devono uscire su MTV?».
Non è così immediato apprezzarne l'effetto oggi che possiamo vederli così, uno dopo l'altro. Ma immaginateveli sparati un po' alla cazzo per la rete senza annunci o spiegazioni: un misto tra la necessità di capirci qualcosa e la voglia matta di raccogliere tutte le figurine per completare l'intera collezione.
Non è un coglione, Rob Gordon. Ne ha digerite di cotte e di crude e se c'è una cosa che ha imparato è che prima di fare la propria mossa è sì importante valutare le carte che si hanno in mano, ma ancora di più lo è ricordarsi quelle che son passate e, di conseguenza, cosa può offrire il mazzo. Quindi, a una rapida scansione, ecco la situazione nell'estate 2000. Da una parte l'mp3 che — dopo essere stato dichiarato cinque anni prima "formato non standard" dal comitato MPEG a favore dell'mp2 — sta vivendo una seconda giovinezza grazie al fenomeno del file sharing illegale, Napster al suo apice di popolarità installato sul 95% dei personal computer americani, i Radiohead — di gran lunga — come la band con più bootleg e fan site non ufficiali in rete. Dall'altra il grande capo Doug Morris della casa madre Universal che, in combutta con la RIAA, sta pensando di citare in giudizio direttamente i singoli utenti che scaricano musica illegalmente (spoiler — lo farà, sul serio), l'industria musicale intera ancora a dir poco sospettosa riguardo a tutto ciò che ha a che fare con internet, e la lobby delle major saldamente unita nel ritenerlo uno strumento del demonio di portata mai vista per aggirare le sante leggi sul copyright.
Il disperato colpo di coda di un pesce alle strette e a corto di acqua? L'intuizione folgorante di un fenomeno della comunicazione? Forse solo il risultato di una semplice equazione: per vendere un palese atto di autosabotaggio commerciale le solite strategie codificate sono solo uno spreco di tempo — serve una campagna promozionale che sia (o almeno appaia) il sabotaggio di se stessa. In sintesi, questi i punti salienti riguardo a cosa non sarebbe stato fatto. Singoli estratti da Kid A: nessuno. Canzoni scelte per girarne un video: zero. Copie dell'album da mandare in anteprima alla stampa: esattamente quante i singoli e i video. Interviste concesse dalla band: con il contagocce.
Tra queste, un esempio che vale più di mille parole: quella rilasciata a David Cavanagh alla band per Q #169, ottobre 2000, la cui prima pagina testimonia un altro aspetto della non-strategia di marketing messa in atto. Allo scopo di sottolineare l'artificiosità del concetto stesso di press kit, tutte le fotografie del gruppo destinate alle riviste sono ritoccate in modo da far sembrare i cinque mostruosi o implausibilmente belli.

Quindi, niente di niente? Non proprio: sarebbe stato allestito un sito speciale dedicato al disco con lo scopo di fornire i blip di cui sopra, altri artwork e informazioni ai siti dei fan, compresi un servizio di messaging buddy (in collaborazione con AOL Instant Messenger) per mettere in contatto gli utenti di tutto il mondo e un calendario di webcast durante i quali presentare a sorpresa le nuove canzoni. Detta in modo che anche i millennial possano capire: i chatbot e il live streaming vent'anni prima dei chatbot e del live streaming.
E dal vivo? Tre date in Nord America — New York, Toronto e Los Angeles — più cinque settimane in Europa. Ambientazioni asettiche: parchi, stadi, autodromi. In un certo senso, i Radiohead si portano dietro la location: suonano infatti sotto un tendone progettato appositamente, con impianto acustico e luci all'avanguardia, proiettori laser, tre maxischermi e nessun cartellone pubblicitario. Da cui il nome, No Logo Tour.

Questo quello che Gordon era riuscito a strappare alla EMI mettendo sul piatto qualcosa come la sua carriera e tralasciando — volutamente — la parte più importante del piano. Ciò che poteva essere la cosiddetta ciliegina sulla torta oppure rivelarsi come il bastoncino fatale quando fai l'ultima mossa (quella, per definizione, sbagliata) a Shanghai — tre settimane prima del previsto arrivo di Kid A sugli scaffali, l'intero disco, traccia per traccia, sarebbe comparso sul web.
Gratis, per usare un eufemismo.
La legge di conservazione della massa (critica)
Rob Gordon non vi dirà mai come sono andate veramente le cose, se ne fosse al corrente o meno, se addirittura sia stata proprio una sua idea. Mica è un coglione.
Da buon laureato in economia all'Università di San Diego, alza le mani e si limita a prendere atto dei fatti e dei numeri, anche se — come sempre — il tono è quello di un Niccolò Machiavelli che ha appena sbancato il tavolo della roulette al casinò di Las Vegas, vendendo sua madre come escort al croupier:
In realtà tutte le nostre azioni — tutto quel giocare a nascondino con il disco — avevano un intento protettivo, conservativo: volevamo salvare Kid A da Napster. Ma che vi devo dire? Mi state chiedendo se quando comparve online sui canali che sappiamo creò più eccitazione, più entusiasmo, un'improvvisa necessità di accamparsi fuori dal negozio per mettere le mani sul CD? Assolutamente sì. Sarebbe successo lo stesso se i pezzi dell'album non fossero stati realmente buoni o non avessero significato qualcosa alle orecchie degli ascoltatori? Dubito fortemente.
Domanda retorica per domanda retorica, col senno di poi, possiamo dire che non sia ormai più nella prima, il punto. Così come non sarà (o comunque non del tutto, non solo) laddove in seguito verranno sprecati fiumi e fiumi di inchiostro, sbuffi su sbuffi di fiato, parole grosse in death-match ogni volta più fini a se stessi. La specificità dei fan dei Radiohead. La loro innata nerditudine (per dire, il CD aveva un secondo booklet: lo hanno trovato solo quelli che hanno avuto l'idea malsana di smontare completamente la confezione come fosse una scatola di LEGO — probabile ci sia ancora qualcuno che nemmeno sa di averlo.). Una band che conosce così bene il proprio pubblico da sentirsela di imbarcarsi nel primo geniale tentativo di bypassare i tradizionali canali di vendita interagendo direttamente con chi i dischi li va a comprare. L'elusione delle pressioni del mercato e l'affidamento della promozione quasi esclusivamente nelle mani di orde di seguaci digitalmente (pre)maturi quanto invasati, che per assurdo produce uno dei più grandi successi commerciali del gruppo.

La seconda questione posta da Gordon invece apre il vaso di Pandora su scenari più interessanti. Il marketing creativo fa miracoli, si sa. Se fantasioso al punto giusto ti permette di vendere ghiaccioli in Antartide. Ma non se quei ghiaccioli fanno schifo. Non due volte di fila almeno, perché il cliente se la lega al dito, lascia una recensione negativa su TripAdvisor e alla prossima occasione va a comprare la solita coppetta al gusto di DO maggiore e crema di bile dagli Oasis. C'è forse traccia di uno scenario del genere nel prosieguo della carriera dei Radiohead? No. Il che ci porta a chiudere subito fuori dai giochi la possibilità di una disamina semplice e lineare, del tipo "ingenui acquirenti fregati da abile venditore di fumo".
E allora cosa è successo? Il pubblico rock stava cambiando pelle e i Radiohead sono stati i più veloci a raccoglierla per foderarci la nuova giacca da fargli indossare oppure i Radiohead hanno mandato a farsi fottere il rock comunemente inteso e tutti gli ascoltatori in massa li hanno seguiti acriticamente in preda a un "effetto-pecora" collettivo? Nuovamente, se il dito medio indica la risposta, stiamo guardando il dito.
Un indizio? Questo è quanto — come in chimica nulla si crea e nulla si distrugge, nel rock niente è mai nuovo e niente sufficientemente vecchio. E così sempre sarà, nei secoli dei secoli. È la teoria di Lavoisier applicata alla musica: una brutta presa di coscienza, lo so — ma qualcuno doveva pur metterla nero su bianco.

Solo un pretesto, ma buono su più fronti
Lo spiega bene Jonny Greenwood, anche se a una prima lettura non capisci se ci è o ci fa:
Quando qualcuno ti dice che stai facendo qualcosa di rivoluzionario nella musica rock, puoi star certo che non si tratta di una cosa seria. È un'utopia. Sarebbe come cercare di fare qualcosa di innovativo nel tip-tap. Quello che abbiamo messo in atto noi è invece una cosa molto vecchio stile. Abbiamo preso un pretesto e l'abbiamo usato come ambientazione per una terapia di gruppo.
Solo che il pretesto era il rock stesso. E quindi ne è uscita una cosa che — sotto un certo aspetto — più rock non si può. Non nel senso duro e puro di chitarre distorte, giubbe di pelle e motociclette che sputano dalla marmitta riffoni a girare in 4/4, ma come impatto iconoclasta su una generazione che cercava un appiglio per non essere risucchiata nello status quo musicale — in momento storico in cui tutto, musicalmente parlando, sembrava diventato status quo — e questo appiglio lo trova nella durezza e purezza con cui una band prova a prendersi la responsabilità di vedere fin dove può portare il proprio sound per non morire dentro le sue stesse piaghe da decubito, senza avere la minima idea (ma, sotto pelle, l'insistente convinzione che non sarebbe stata trascurabile) dell'enorme massa di persone che avrebbe continuato a seguirla.

Il fatto che abbia funzionato (quanto bene abbia funzionato e soprattutto, il modo che ha trovato per funzionare) credo sia qualcosa che ha a che fare con l'adolescenza. O, meglio ancora, con la visione che, dell'adolescenza, ha chi se la sta iniziando a vedere scivolare via da sotto il culo. Con il ricordo — ancora ben vivido — dell'adolescenza, diciamo. E alla fine della fiera, cosa c'è di più ingenuamente "rock" della voglia di tenere accesa la fiammella di quel ricordo, di continuare a viverlo più a lungo possibile? Dopotutto, il rocker che si rifiuta di crescere e mettere la testa a posto è uno degli stereotipi più classici, no? Quella specie di Peter Pan col chiodo e ormai pochi capelli che veste i panni del vostro zio cinquantenne ancora in fissa con i Motörhead mentre tutti si prendono gioco di lui. Ci siamo capiti.
Ecco, in ogni epoca la cosa si declina in maniera diversa. Chi ascoltava rock e l'adolescenza iniziava a sentirsela scappare dalle mani a cavallo del cambio di millennio, in Kid A aveva trovato il modo per arrivare a cinquant'anni facendo il rocker senza che nessuno osasse prendersi gioco di lui.
A-Kids
Li hanno chiamati mid-noughties, e forse non è un caso se in inglese l'assonanza è forte con i mid-90s. Nei primi anni Duemila — proprio come a metà del decennio precedente (anzi, probabilmente proprio per l'effetto di quello che era successo allora) — i concetti di "alternative" e "mainstream" erano ormai quasi indistinguibili sotto uno spesso strato di lardo da cui tutti (mass media ed etichette discografiche, ma non solo) trovavano un ipercalorico sostentamento. Budget gonfiati come non mai avvicinavano pericolosamente Kaiser Chiefs e Sugababes, Arctic Monkeys e Shania Twain: sembrava non ci fosse spazio per una qualche idea di underground dove rifugiarsi e sentirsi diversi (qualunque significato si volesse dare al termine — dal lurido ghetto alla spocchiosa élite, e tutte le cinquanta sfumature di disagio che stanno nel mezzo).
È qui che gli appena freschi post-adolescenti — equipaggiati se non altro con i loro rumorosi modem sopravvissuti alla paura del millennium bug — (battezziamoli pedissequamente A-Kids) si aggrappano a Kid A come al messia e guardano alla sua coraggiosa sfida in qualche modo sperimentale come unica guida e alternativa possibile.
Come è andata lo sappiamo, perché eravamo noi. Abbiamo messo in atto un take-over di internet, ronzato in veste di sciame impazzito attorno al miele che colava dal forcone appuntito di Pitchfork (ricordiamo tutti — ancor prima delle sue parole — il voto epico, coraggiosamente scelto da Brent DiCrescenzo a simbolo di una svolta in doppia cifra: un'assenza di dubbi per una volta tonda e piena, senza i famosi decimali che già erano un marchio della webzine, oggi approfondimento culturale a marca Condé Nast), dato vita a quel ricettacolo di genio puro e puttanate colossali che è stato la cosiddetta "blogosfera", partorito dal nulla di MySpace e compagnia cantante band interessanti come i Foals e altre meno digeribili come gli Animal Collective (o viceversa).
Nel bene e nel male ci siamo virtualmente rimboccati le maniche e abbiamo sviluppato quello che mancava: una nuova sotto-cybercultura digitale. Kid A era il suo totem, e non poteva essere diversamente.
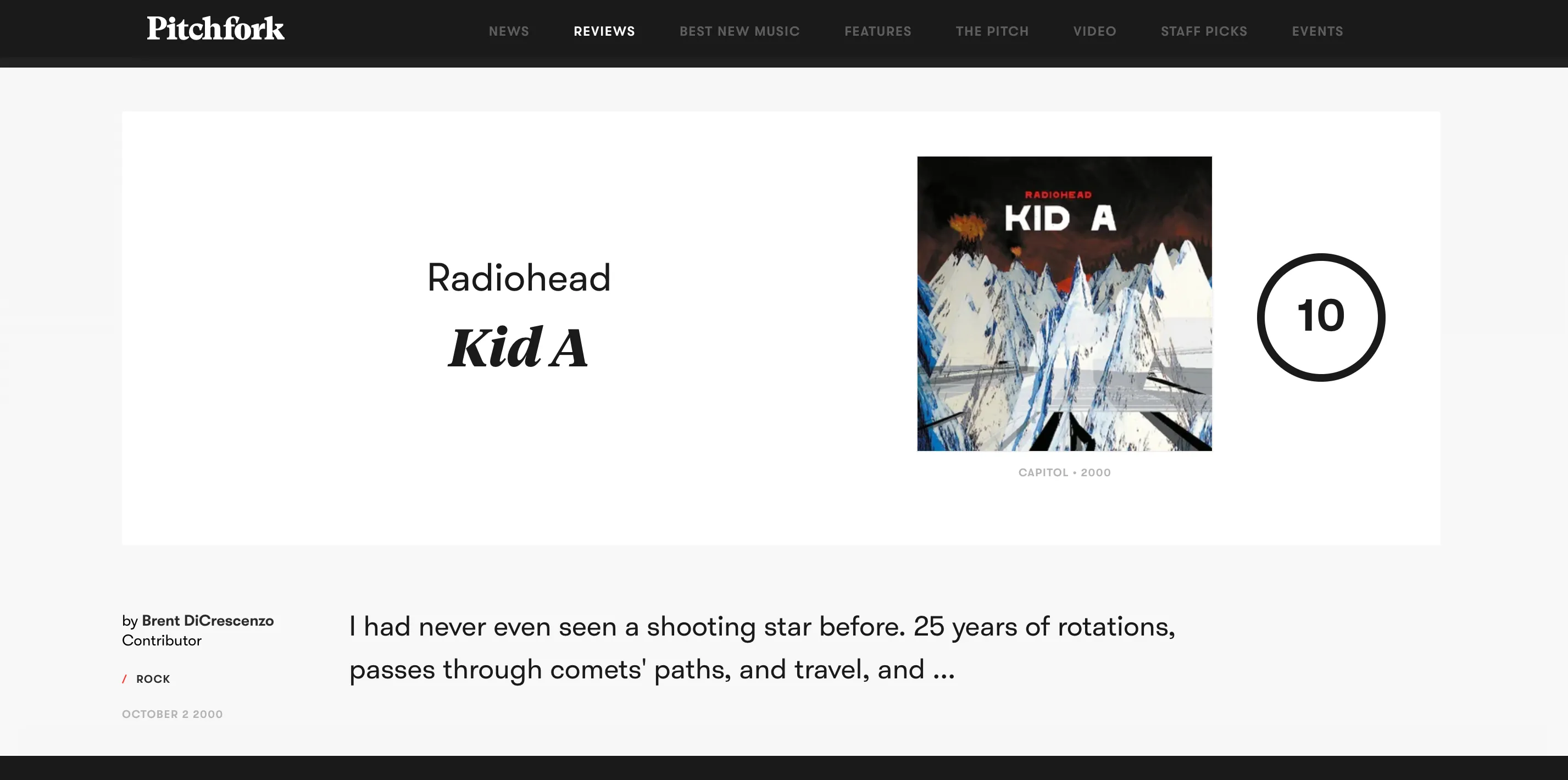
Pisciare fuori dal vaso
Perché? Perché i Radiohead sono (e sempre saranno) la band tardo-adolescenziale per eccellenza. Non importa quante colonne sonore Jonny Greenwood comporrà per Paul Thomas Anderson, quante suite per orchestra si tirerà fuori dalla testa, quante volte riuscirà a fregarci spacciando il suono di un ondes martenot per un effetto della pedaliera di una Telecaster. Non importa quante playlist techno condividerà Thom Yorke su Twitter o a quanti cortei a tema climate change parteciperà attivamente. Non importa quanti batteristi riusciranno a mettere su un palco contemporaneamente, in quanti progetti paralleli o solisti si imbarcheranno gli altri componenti del gruppo, quali altri stratagemmi si inventeranno per venderci un disco mentre ci convincono che ce lo stanno regalando.
Non importa. Perché mai riusciranno a fare a meno di quello che è un loro tratto genetico e che, allo stesso tempo, è — proprio dell'adolescenza — la componente più esplosiva: una meravigliosa, quasi commovente, tendenza a pisciare fuori dal vaso. Nella zona dell'Oxfordshire si dice "over-egg the pudding" e suona molto meno volgare, anche se va ad aumentare i livelli di colesterolo, ma il significato è chiaro. Prendete il senso di dare in pasto a MTV un singolo come Paranoid Android (e il relativo video), chiedetevi che bisogno c'era di specificare che i plastic trees fossero anche fake (e provate a immaginare quanto meno efficace quel ritornello sarebbe stato se non lo avessero fatto), o perché abbiano tenuto il loro pezzo migliore a marcire in una versione lo-fi da falò sulla spiaggia per pubblicarlo infine ventun anni dopo in una veste irriconoscibile (ma ugualmente straziante) — e capirete cosa intendo.
Poi prendete Kid A, riascoltatelo in quest'ottica, dove il minimalismo è uno specchietto per le allodole con pochi pixel di risoluzione che non riesce a distrarre dall'alta definizione di un incorreggibile, complicato talento. Lo troverete ancora più emozionalmente iperbolico di tutte queste cose messe insieme. Elettronica, kraut-rock, jazz, musica classica? Autechre, Leftfield, Charlie Mingus, Miles Davis, Björk, Tom Waits? Sto tirando a caso, perché vale tutto. Largo all'avanguardia, dicevano quelli che volevano assicurarsi che il loro pubblico non fosse solo un pubblico di merda.

Sentirsi sbagliati al momento giusto
A fine anni Novanta, i Radiohead di Kid A sembravano l'unica band sopravvissuta agli anni Novanta che ancora volesse essere una band anni Novanta, che ancora aspirava a comprimere in un unico sfogo i rimasugli della famosa teenage angst e il terrore dell'età adulta, l'anticipazione di una rivolta geopolitica strisciante e la bramosia di una passione le cui quotazioni ovunque sembravano in calo. Il fatto che, per farlo, stessero ingenuamente provando a non assomigliare alla band che erano stati negli anni Novanta era tutto meno che ridicolo: rendeva la questione ben più interessante, il tentativo ben più rispettabile e — dal loro punto di vista — probabilmente drammatico, come ogni cosa appare durante l'adolescenza, appunto.
Era bello vederli puntare a una statura (forse morale ancor prima che musicale) che quasi tutte le altre big band del loro stesso periodo avevano — a volte inconsciamente, altre per puro calcolo strategico, altre ancora per cause di forza maggiore — troppo presto abbandonato. Kurt Cobain si era ammazzato, Tupac e Biggie si erano fatti ammazzare, Pearl Jam, R.E.M. e U2 ormai erano già adagiati su un letto di allori fatto di semplice (a tratti pure di alto livello qualitativo, ma qui si aprirebbe un altro dibattito) mestiere. Rock, pop, rap — era difficile trovare riferimenti.
Non voglio arrivare ai livelli di Chuck Klosterman che — come prova inconfutabile di quanto Kid A sia stato espressione perfetta del suo tempo e di quello immediatamente a venire — tira su un'avvincente teoria secondo cui i testi del disco stessero pronosticando, riga per riga, i tragici fatti dell'11 settembre 2001. Molto più semplicemente, quella di Kid A è musica composta da dei trentenni che non riescono a farsi una ragione del fatto che ogni cosa a cui tenevano quando di anni ne avevano venti sia andata a puttane così male e così in fretta. Musica piena di dubbi esistenziali privati e imbarazzo per se stessi: il grido di cinque artisti che hanno dedicato la loro vita a qualcosa di importante (anche fosse soltanto diventare la più grande rock band di sempre) e ora si stanno chiedendo se davvero ce l'hanno fatta. E se ha senso provare ad alzare ancora il livello. E come riuscirci senza iniziare ad avere paura di guardarsi allo specchio la mattina.
Il fatto è che i Radiohead non erano gli unici a sentirsi così, a inizio 2000, e questo — come spesso, banalmente, accade — è il vero, semplice motivo per cui Kid A è entrato a tal punto in risonanza con un generico pubblico rock, nonostante di rock sembrasse avere quasi nulla e a dispetto dell'apparentemente insensata operazione zero-airplay.

The gentle art of making enemies
A questo aggiungiamo il fatto che — su, siamo onesti — quella sì che era roba su cui era divertente dibattere. Che lo abbiate amato o odiato, Kid A ha dato a chiunque il diritto di una voce in capitolo e la conseguente dose di intrattenimento che ogni — come li chiameremmo oggi — flame si porta appresso. Capolavoro o solo hype? Un pedestre compendio di cliché frutto della paura di assomigliare troppo a se stessi o una fuga in avanti che sta spezzando le gambe agli inseguitori? L'album della svolta verso il ventunesimo secolo o esoterico art-rock masturbativo? Un lungo e rimuginato errore o un'ossessione a cui dare una chance per farsi conquistare? Reggerà la prova del tempo? Quando esce la seconda parte (sai, quella con dentro le vere canzoni dei Radiohead)? Sta sul serio arrivando l'era glaciale? Sta succedendo davvero?
Ora che la discussione è ampiamente superata e che ogni controversia riguardo a Kid A pare collassata addosso alla comune definizione di disco epocale, possiamo dirlo: qualcosa è andato perso. E, di nuovo, è un qualcosa che ha a che fare con l’adolescenza. Si tratta di quel bisogno di trovare un nemico da combattere, mettere in difficoltà o anche solo deridere per identificare se stessi. Tutto il concept originale dell'album infatti — inconsapevolmente o meno — richiede un antagonista, in primis la ben rodata narrativa secondo cui "fanculo, un artista deve essere libero di fare la sua cosa, senza imposizioni di sorta", che — a sua volta — necessita di qualcuno che reciti il ruolo di colui che, all'artista, vorrebbe impedire di fare la sua cosa, adducendo motivazioni troppo pragmatiche per il concetto stesso di arte. Che questo qualcuno sia una casa discografica interessata solo a far tornare i conti o una schiera di fan che avrebbe preferito di gran lunga un onestissimo OK Computer (vol. 2), non fa tutta questa differenza. Oggi invece, chiunque sia — anche solo vagamente — interessato ai Radiohead, sembra non avere dubbi sul valore di Kid A. Si discute sull'effettiva necessità di The King of Limbs o sul senso e sul retrogusto di A Moon Shaped Pool, si scherza su Thom Yorke per le sue derive soliste e danzerecce, ma in pochi ammettono che a suo tempo Kid A l'hanno odiato, ne sono rimasti delusi o non l'hanno capito.
Sarà che il passare delle stagioni porta consiglio, ma è un processo già visto: una sorta di negazionismo — tanto comprensibile quanto impacciato — che progressivamente toglie alle cose il valore aggiunto dell'impatto che hanno avuto e le mette pericolosamente in bilico su un piedistallo fuori dalla cronologia, in una beatificazione democristiana che omologa tutto (seppur verso l'alto) con gli occhi appannati di un ricordo ritoccato. Per dire, c'è qualcuno che ancora rinfaccia a Dylan la sua svolta elettrica? O qualcuno che nel '94 ha votato Berlusconi? Improbabile.
Una specie di maledizione
Eppure i suoi detrattori, tutt'oggi avrebbero i loro sporchi ganci a cui attaccarsi. Perché — a livello strettamente tecnico — è vero quello che dice Jonny Greenwood: gli elementi di base di Kid A — accordi, melodie, ritmi — sono vecchi come la musica stessa. La maestria con cui combina effetti elettronici in stile Warp può sembrare — almeno ai più intransigenti esegeti dell'IDM — a tratti maldestra e già datata (e sì, probabilmente è stata pure sovrastimata, in retrospettiva, dai suoi successori). A voler essere sarcastici si potrebbero ricordare e far proprie le parole con cui accolse il disco Select — uno dei magazine britpop più cool dell'epoca — a pagina 108 del numero di novembre 2000, così da garantirsi una figura quantomeno brillante per la durata di un tweet:
Cosa vogliono per aver rattoppato un album con la roba che Aphex Twin faceva nel '93, una medaglia?
Ma d'altro canto anche le tracce apparentemente più fiacche denotano una certa audacia e i suoni — semplicemente stratosferici — confessano un lavoro e una dedizione passionale e certosina, quasi al livello di un'ossessione patologica, se non altro in termini di diottrie perse (e scoliosi guadagnata) chini sopra un laptop. Dalla prima all'ultima traccia del disco, i Radiohead di Kid A appaiono spavaldamente incerti, confusi eppure meravigliosamente pieni di sé. Minuto dopo minuto, bizzarra trovata dopo bizzarra trovata, sottrazione dopo sottrazione, più cercano di non assomigliare a un gruppo rock, più sembrano la più credibile rock band in attività e trasudano quella tipica magniloquenza che — da sempre — del rock old school ha storicamente rappresentato la base, sia quando è stata declinata nella semplicità di una pentatonica blues che quando si è arrampicata sulle vette della sboroneria progressive.
Proprio questa, da Kid A in avanti, sarà allo stesso tempo la loro condanna e la loro grandezza: non sbagliarne mai una provando a sbagliarle tutte e finire a farsi un culo così per campare di rendita su una rendita da cui — ogni santa volta — idealmente provare a prendere le distanze. Amnesiac uscirà — contro qualunque logica di mercato — solo sei mesi dopo con addosso la puzza pesante di raccolta di B-side (i più maligni ipotizzeranno scarti) e nella prima settimana venderà il doppio del suo predecessore, In Rainbows verrà dato in pasto ai fanatici del download con la formula "pay what you want" e frutterà circa tre milioni di sterline (comprese le centomila copie segnate dal discbox in edizione limitata e i quasi due milioni di CD fisici — formati, entrambi, che vedranno la luce solo successivamente alla versione digitale, ovvero quando tutti conoscevano l'album ormai a memoria). Il resto poi, è storia moderna.
Essere i Radiohead
Non che debba stupire, la piega presa dalle cose: la necessità di appendere subito al chiodo l'etichetta di one-shot band ha stretto un cappio virtuale attorno al collo del gruppo fin dall'inizio (chiedete a tutti quelli che hanno aspettato diciotto anni prima di poter riascoltare Creep dal vivo), ma Kid A in questo senso è un vero e proprio spartiacque. Un intrigante cammino nella mente di cinque straordinarie individualità di fronte ai propri reciproci demoni, perplessità e paure. Il momento in cui la band fa ufficialmente coming out e dichiara di voler iniziare a esistere come collettivo di creativi e di volerlo fare altrove, provando a scomparire sotto la superficie del rock emerso per sperare di riaffiorare tutta bagnata (ma meno persa) nelle baie calme di canali creati quasi ex novo e ad hoc.
Facile rischiare quando sai che puoi permettertelo, diranno i più cinici. Può darsi, ma è un dato di fatto che i Radiohead, il fatto di essere i Radiohead, mai hanno voluto, mai hanno potuto, mai hanno saputo prenderlo alla leggera. Un po' per natura, un po' perché ogni loro mossa da un lato ha contribuito a determinare l'immenso valore stesso di essere i Radiohead, dall'altro ha finito per creare una specie di follia collettiva irrisolvibile attorno al bisogno che proprio loro lo fossero, i Radiohead. Kid A e l'apparato antipromozionale che gli si è evoluto attorno — e che successivamente è stato replicato sotto altre mutevoli forme — sono stati benzina sul fuoco in questo senso (forse sarebbe più opportuno dire "acqua sui Gremlins") e hanno dato il via a un processo di moltiplicazione di un pubblico compiacente (con tutti i pro e i contro del caso) che ha portato questa follia a livelli schizofrenici sostanzialmente mai visti negli annali recenti e che — paradossalmente, per contro — ha concorso a riattizzare la scintilla del mitologico dualismo "eroe vs. antagonista" (opportunamente declinato in "sono dei geni assoluti" vs. "hanno rotto il cazzo") che si trascina e si autoalimenta tutt'ora, sia nei salotti della critica musicale gourmet che nei discorsi del rocker di strada, sudato a torso nudo, in fila davanti al camioncino del piadinaro per una salsiccia mezza cruda e uno shottino di birra scadente alla modica cifra di 19€ in forma di comodi token di grosso taglio.
Eppure c'hanno provato, vent'anni fa. E noi abbiamo amato guardarli mentre ci provavano con così tanto impegno, quando tutti gli altri erano in ritirata. C'hanno provato, e nel tentativo di reinventarsi sagoma sfocata di un'entità elusiva e sfuggente, hanno dato alla luce un disco che — con il suo mero e semplice esistere — ha fatto niente altro che intricare la trama del proprio racconto e intensificare il loro culto globale.
Vent'anni dopo, è ancora un gran bel sentire. Se poi siete tra coloro che sostengono la teoria paranoica secondo cui il fatto che il racconto valga qualcosa implica necessariamente che valga più della sua stessa musica, allora lasciatevelo dire, senza nessun rancore: non avete capito un cazzo. Né di musica, né dei modi possibili di raccontarla. O venderla.
Parola di Rob Gordon.