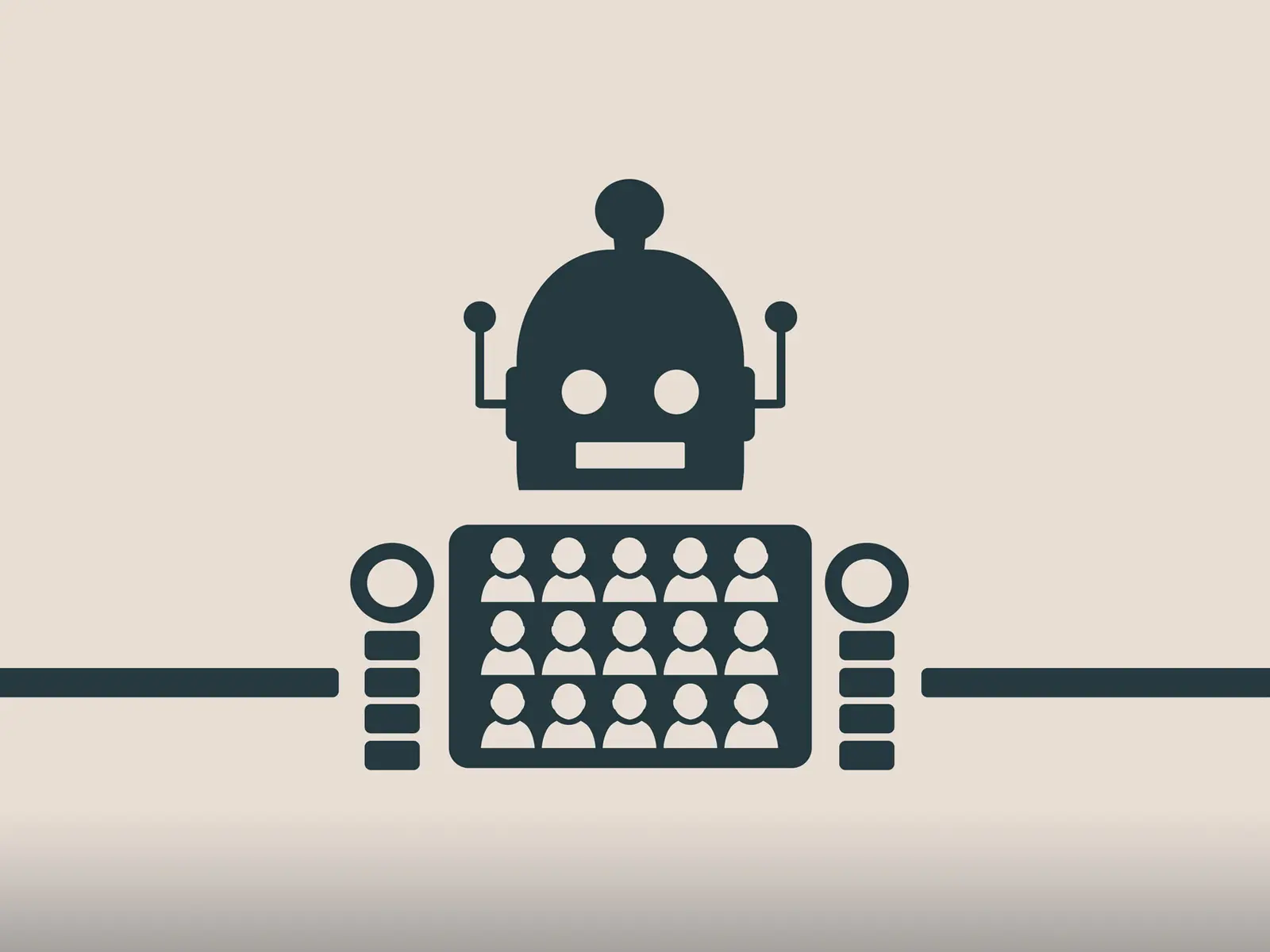
HVSR Digest #11
Bonnie Prince Billy, Jeanne Added, Amnesia Scanner, Get Well Soon, Phantastic Ferniture: cinque pezzi buoni per rassegnarsi a stare in casa quando tutti sono in ferie.
31 Luglio 2018
Bonnie Prince Billy
Blueberry Jam
Mirtillo nero: proprietà benefiche e controindicazioni
Spero vi piacciano i mirtilli, perché altrimenti — se tipo siete allergici al miracoloso frutto di bosco — probabilmente è già troppo tardi. Nel caso, mi scuso umilmente per le conseguenze provocate.
Il che sarebbe comunque un peccato, viste le loro caratteristiche naturalmente antiossidanti, antinfiammatorie e vasodilatatorie che contrastano i radicali liberi combattendo così l'invecchiamento cellulare. È vero, hanno un costo al grammo che fa concorrenza ai prezzi da strozzino del Compro Oro sotto casa, ti lasciano la lingua colorata per giorni come le peggiori Big Babol e il loro succo ha più o meno il sapore dell'acqua sporca, ma d'altra parte si sa: se gli zuccheri, i trigliceridi e i grassi saturi fossero una manna dal cielo per la salute, da un lato vivremmo nel migliore dei mondi possibili, dall'altro dovremmo dar ragione agli Weezer. A voi decidere se sarebbe una prospettiva allettante o meno.
E invece quelle piccole sfere violacee sono la soluzione DIY più indicata per problemi cardiocircolatori, aumentano la velocità di rigenerazione della porpora retinea, vanno bene per coliche e cistiti e in generale, quando tutto sembra stia andando a rotoli, aiutano a tirare su il morale.
O almeno questo è quello che si evince dal nuovo, assurdo pezzo di Will Oldham a sentire il quale i mirtilli sono essenzialmente la cura per tutto. Di più: sono la cosa più fica sulla faccia della terra e qualunque altra roba vi possa venire in mente (che sia Amazon Prime, Jenna Jameson o la penicillina) mai potrà essere all'altezza di una loro sana scorpacciata.
Ecco quindi spiegata l'urgenza — così, senza nemmeno un album nuovo all'orizzonte, solo un misero singolo che, se fossimo in un altro periodo storico, chiameremmo "45 giri" — di questa ode divertita e spassionata e del suo video low-budget, che vede un Bonnie Prince Billy fin troppo simile Tobias Fünke (quando in Arrested Development prende quella brutta fissa per il Blue Man Group) e la sua dolce metà decantarci le lodi del blueberry e dare sfoggio del suo innato talento per le rime baciate, elencando tutte le possibili assonanze che la lingua inglese offre per quella splendida parola (verso la fine, in un momento di crisi di fantasia (oppure in un picco di creatività, dipende dai punti di vista) tira in ballo pure sua zia Teri, la sperduta cittadina di Tucumcari nel New Mexico e uno stiracchiatissimo Fred Astaire.).
C'è pure un mirtillo scontornato male che danza sulle parole guidando il karaoke: un potpourri del grottesco così agghiacciante che non ha bisogno nemmeno di un ritornello, perché solo con tre strofe in croce farà — che lo vogliate o no — nelle vostre teste e ci rimarrà ostinato almeno per tutta l'estate.
Get Well Soon
Martyrs
Nouvelle vague tedesca e psycho-thriller in salsa kraut
Konstantin Gropper non ha mai amato le mezze misure, gli approcci minimalisti, i bassi profili. In altri termini, l'ormai ex bambino prodigio tedesco è sempre stato uno che non ha mai avuto paura di ridurre il fin troppo abusato concetto di less is more a quello che — semanticamente, a tutti gli effetti — è: un controsenso.
Laureato in filosofia e figlio di un famoso insegnante di musica classica ha iniziato — anche lui come tutti — nella sua cameretta. Solo che nella sua cameretta c'erano: un violoncello, un pianoforte, una tromba, tre chitarre e tutta una serie di aggeggi analogici e digitali per registrare i suoi ambiziosi cazzeggi di multistrumentista in erba in maniera egregiamente professionale. Deve essere per questo che i Get Well Soon — la sua idea di band, ovvero sei persone che lo aiutano a suonare dal vivo le cose che lui compone in rigorosa solitudine — hanno sempre tradito, fin dai primi tempi in cui cercavano di mischiarla con un semplice indie-rock, una certa magniloquenza e teatralità che, negli anni, è traboccata fuori dal vaso rivelando la sua vera essenza di musica sinfonica contemporanea finemente arrangiata in un'ottica via via sempre più cinematica e cinematografica.
Così cinematica e cinematografica che a questo giro, per promuovere il suo nuovo disco, The Horror, il nostro piccolo dandy ha deciso di produrre, invece che il solito, banale videoclip, un vero e proprio film, diviso in quattro episodi, comparsi da poco online a distanza di una settimana l'uno dall'altro.
Questo il pilot iniziale, che getta le basi della la storia allucinante e allucinata di Christine e Jean, marito e moglie in crisi che tentano di esorcizzare i propri problemi e i propri incubi con una terapia di coppia che sembra piuttosto il frutto di una cena a due tra Roman Polanski e Lars Von Trier. Dopo il decimo ammazzacaffè, s'intende.
Per chi vuole sapere come va a finire, qui, qui e qui ci sono le tre parti successive. Quelli che invece non hanno tempo da perdere e sono interessati solo alle canzoni, saltino pure direttamente al minuto 5:35, dove inizia sul serio Martyrs, il primo singolo tratto dall'album — o almeno ciò che ne rimane dopo che è stato opportunamente decostruito e riadattato agli scopi del lungometraggio (i puristi troveranno comunque qua la versione originale).
Piaccia o non piaccia, rimane un fatto innegabile: in un'epoca in cui l'unico obiettivo di chi ha le mani in pasta nel music business pare essere diventato quello di sfornare tutorial su come strutturare la canzoncina perfetta che in meno di tre minuti scali le classifiche di Spotify, un progetto del genere si pone come un'inversione a "U" contromano, un atto di resistenza bellissimo e commovente che, cosparso di una perfetta inutilità che rasenta il suicidio commerciale, diventa una cosa — a modo suo — estremamente romantica.
Romantica nel senso di Goethe.
Jeanne Added
Radiate
Mai la Francia è suonata così sul pezzo
Sarà che la storia la fanno i vincitori e i mondiali di calcio sono appena finiti come sono finiti, ma non deve essere un caso se, nemmeno il tempo di digerire i festeggiamenti sugli Champs-Élysées, e già sbucano francesi da ogni dove — tipo le lumache nei vialetti dopo uno scroscio di pioggia — a pretendere di insegnarci come fare le cose.
Nello specifico, qui c'è una fille blonde col ciuffo che ha deciso che il futuro prossimo suona così: un po' art-pop sofisticato, un po' dark-electro in slow motion, un po' cold-wave intiepidita, un po' sticazzi. Tocca rosicare abbastanza a confessarlo (dar ragione ai francesi, dico — io non l'ho mai scritto, tu non l'hai mai letto), ma è un modo come un altro per dire che suona parecchio, parecchio bene.
Sì, perché Jeanne Added è così francese che trovare una recensione di un suo disco in una lingua diversa da quella de La Marsigliese è un'impresa e probabilmente le sue canzoni suonano meglio su Deezer che su Spotify, eppure riesce sempre e comunque a fregarti con un sound tanto attuale quanto universale e ogni volta un passo avanti sui tempi (supplementari compresi).
Venuta alla ribalta — come Dario Hubner — relativamente tardi, tre anni fa ci aveva impacchettato alla grande il suo sensazionale album di esordio, dove metteva insieme tutto ciò che aveva imparato nel frattempo, tra gavetta, conservatorio, jazz club e collaborazioni varie (Dan Levy e i The Dø su tutti). Oggi torna in pista ancora più consapevole dei propri mezzi, contemporaneamente algida e sensuale come solo le ragazze d'oltralpe sanno essere, ben conscia di risultare una bestia rara quanto un cocktail preparato in laboratorio: qualche traccia di Peaches ma meno svitata, un po' di La Roux ma meno paracula, abbastanza Tying Tiffany ma meno figa (e anche meno tamarra), sempre più St. Vincent ma meno patinata. Basta poi riempire fino all'orlo lo shaker con il vero ingrediente killer — ovvero una voce di gran lunga al di sopra di quella di tutte e quattro messe insieme — per ottenere un mix quasi illegale: cattivo quanto basta per restare ancora dolce, malinconico al punto giusto per rimanere estremamente cazzuto.
Phantastic Ferniture
Fuckin 'n' Rollin
La tristezza è bella quando dura poco
È vero, la felicità è puttana e quasi mai rilascia regolare fattura, ma anche fare della fedeltà alla malinconia un mestiere alla lunga stanca e finisce che ci devi pure pagare i contributi.
Lo spiega meglio Julia Jacklin:
I'd gone straight into folk music, so every experience I'd had on stage was playing sad music with a guitar in my hand. I thought, I would love to know what it's like to make people feel good and dance.
Nel senso, quando hai venticinque anni ed esordisci con un debutto che riscuote un immediato successo tra gli irriducibili del genere al punto da ritrovarti sommersa dagli applausi di gente che potrebbe essere tuo nonno durante la tua prima apparizione in venerate (e venerabili) rassegne come il Newport Folk Festival, due domande — prima di morire acustica — magari te le fai.
Poi da lì a ricontattare due vecchi amici di infanzia e chieder loro di formare una band un po' scazzona da chiamare con due parole che non esistono in nessun vocabolario di inglese, è un attimo.
Nati quasi per scherzo, tra i tavoli del Frankie's Pizza di Sidney, come un drunken agreement tra la giovane australiana, Elizabeth Hughes e Ryan K Brennan, i Phantastic Ferniture in poco più di un anno sono diventati — pur rimanendo coerenti con l'iniziale patto di disimpegno: «Don't overthink it» — qualcosa di decisamente più serio, così serio che a fine Luglio è prevista l'uscita del loro omonimo primo album.
Il singolo che lo anticipa mantiene esattamente quello che promette, ovvero un indie-rock giocoso che se volete potete definire garage-pop, ma non rende l'idea. Fortuna che — come spesso accade — quando siamo a corto di parole, ci vengono in aiuto le immagini e, nello specifico, la clip girata da Nick Mckk, verosimilmente seguendo uno script all'altezza della situazione: «Vagabondate per il quartiere facendo i cretini, l'importante è che sembriate contenti e spensierati, anche a costo di sembrare ridicoli.»
Ne esce una specie di parodia scanzonata del video di The Suburbs degli Arcade Fire, interpretato però dai figli degli Hanson, vestiti con i costumi dei padri. La notizia è che funziona alla grande, perché — nonostante le giustificatissime perplessità di partenza — nemmeno te ne accorgi, eppure all'attacco del primo ritornello sei già lì con loro, a scorrazzare sui marciapiedi della periferia della vita, senza troppe menate in testa né una destinazione precisa in mente, ma solo un unico, ben confuso programma per la serata: fuckin 'n' rollin.
Amnesia Scanner
AS A.W.O.L.
La fine del mondo e perché vale la pena aspettarla
La complicata (ma pur sempre stimolante) narrativa da creare attorno al "misterioso producer" è ormai poco più che un cliché. Poteva funzionare agli albori di internet, ma oggi (quando con un semplice account GMail o Facebook ti sei già fottuto l'intero il carnet di dati personali che la società di ha lasciato in dote — i tuoi e quelli di tutta la tua famiglia, per essere precisi) suona un po' ridicolo e già visto. Nonostante questo, viene ciclicamente replicata ogni paio d'anni anche se, in termini di qualità, le statistiche dicono che il gioco non vale troppo la candela. Nel senso, per trovare un Burial tocca sorbirci almeno cento Liberato.
Gli Amnesia Scanner hanno giocato con mano pesante, in questo senso (un sito che per lungo tempo è stato niente'altro che un mix cacofonico di visual improponibili, comunicati stampa pieni di link senza nome che portavano a sospetti file su MediaFire o a homepage di archivi di molecole biologiche tridimensionali — cose così), senza paura di scottarsi con la fiamma della candela, forti di una proposta musicale a suo modo unica, capace di mettere in secondo piano tutta la retorica infantile del teatrino costruito attorno alle loro vere identità: un'elettronica organica, claustrofobica e disorientante, estremamente densa ma mai troppo complessa, urticante e indefinibile, che va ben oltre la ridicola definizione di neo-savage avant-EDM senza, sapientemente, mai oltrepassare quella soglia proibita al di là della quale diventi imballabile.
Il gioco di cui sopra — si sa — è anche bello quando dura poco, così oggi abbiamo scoperto che dietro la consolle si celano Ville Haimala e Martti Kalliala, siamo capaci di geolocalizzarli con una certa precisione (diciamo finlandesi mai ormai stabilmente trapiantati a Berlino) e conosciamo il loro curriculum precedente (gli inizi come Renaissance Man, gli intrallazzi con il collettivo Janus, la collaborazione con Holly Herndon). Non molto, ma sempre meglio di niente.
Le prime uscite a nome AS (un anagramma del loro precedente moniker) sono comparse online nel 2014. Da allora: due EP, una roba che se volete potete chiamare "podcast" anche se sembra più la versione horror-tecnofuturistica di un vecchio radiodramma RAI e un'altra cosa che è stata vagamente confinata nel recinto dei "progetti multimediali" ma in realtà è un trip digitale senza fine (sta online — qui — e non c'è modo né di metterlo in pausa né di scorrere avanti o indietro). Nemmeno un disco intero, insomma. Eppure son riusciti lo stesso un paio di volte a finire nelle migliori classifiche degli album di fine anno. Lo so: viviamo in un mondo incoerente.
Accontentiamoci quindi almeno del fatto che il tanto attesto full-length sta per arrivare: si chiamerà Another Life e AS A.W.O.L. ne è solo un assaggio, che altro non fa che confermare il talento visionario dei due, sempre perfettamente in bilico tra le due facce storte del concetto di no hope. Un rassegnato avvertimento in vista dell'apocalisse che incombe o il semplice invito ad aspettare la fine del mondo tutti sudati sui resti di un qualche dancefloor? Entrambe le cose, ovviamente.